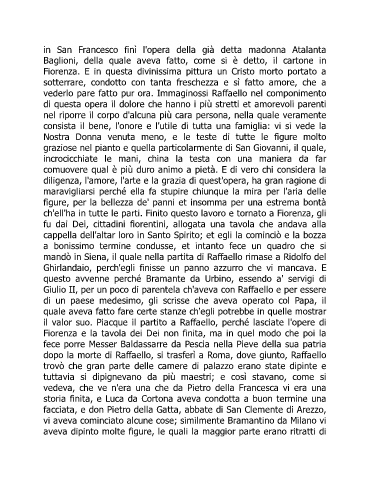Page 842 - Giorgio Vasari
P. 842
in San Francesco finì l'opera della già detta madonna Atalanta
Baglioni, della quale aveva fatto, come si è detto, il cartone in
Fiorenza. E in questa divinissima pittura un Cristo morto portato a
sotterrare, condotto con tanta freschezza e sì fatto amore, che a
vederlo pare fatto pur ora. Immaginossi Raffaello nel componimento
di questa opera il dolore che hanno i più stretti et amorevoli parenti
nel riporre il corpo d'alcuna più cara persona, nella quale veramente
consista il bene, l'onore e l'utile di tutta una famiglia: vi si vede la
Nostra Donna venuta meno, e le teste di tutte le figure molto
graziose nel pianto e quella particolarmente di San Giovanni, il quale,
incrocicchiate le mani, china la testa con una maniera da far
comuovere qual è più duro animo a pietà. E di vero chi considera la
diligenza, l'amore, l'arte e la grazia di quest'opera, ha gran ragione di
maravigliarsi perché ella fa stupire chiunque la mira per l'aria delle
figure, per la bellezza de' panni et insomma per una estrema bontà
ch'ell'ha in tutte le parti. Finito questo lavoro e tornato a Fiorenza, gli
fu dai Dei, cittadini fiorentini, allogata una tavola che andava alla
cappella dell'altar loro in Santo Spirito; et egli la cominciò e la bozza
a bonissimo termine condusse, et intanto fece un quadro che si
mandò in Siena, il quale nella partita di Raffaello rimase a Ridolfo del
Ghirlandaio, perch'egli finisse un panno azzurro che vi mancava. E
questo avvenne perché Bramante da Urbino, essendo a' servigi di
Giulio II, per un poco di parentela ch'aveva con Raffaello e per essere
di un paese medesimo, gli scrisse che aveva operato col Papa, il
quale aveva fatto fare certe stanze ch'egli potrebbe in quelle mostrar
il valor suo. Piacque il partito a Raffaello, perché lasciate l'opere di
Fiorenza e la tavola dei Dei non finita, ma in quel modo che poi la
fece porre Messer Baldassarre da Pescia nella Pieve della sua patria
dopo la morte di Raffaello, si trasferì a Roma, dove giunto, Raffaello
trovò che gran parte delle camere di palazzo erano state dipinte e
tuttavia si dipignevano da più maestri; e così stavano, come si
vedeva, che ve n'era una che da Pietro della Francesca vi era una
storia finita, e Luca da Cortona aveva condotta a buon termine una
facciata, e don Pietro della Gatta, abbate di San Clemente di Arezzo,
vi aveva cominciato alcune cose; similmente Bramantino da Milano vi
aveva dipinto molte figure, le quali la maggior parte erano ritratti di