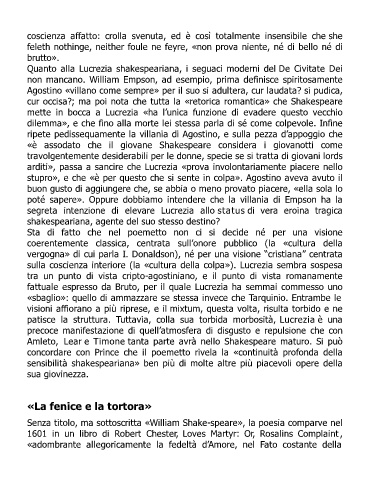Page 2117 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2117
coscienza affatto: crolla svenuta, ed è così totalmente insensibile che she
feleth nothinge, neither foule ne feyre, «non prova niente, né di bello né di
brutto».
Quanto alla Lucrezia shakespeariana, i seguaci moderni del De Civitate Dei
non mancano. William Empson, ad esempio, prima definisce spiritosamente
Agostino «villano come sempre» per il suo si adultera, cur laudata? si pudica,
cur occisa?; ma poi nota che tutta la «retorica romantica» che Shakespeare
mette in bocca a Lucrezia «ha l’unica funzione di evadere questo vecchio
dilemma», e che fino alla morte lei stessa parla di sé come colpevole. Infine
ripete pedissequamente la villania di Agostino, e sulla pezza d’appoggio che
«è assodato che il giovane Shakespeare considera i giovanotti come
travolgentemente desiderabili per le donne, specie se si tratta di giovani lords
arditi», passa a sancire che Lucrezia «prova involontariamente piacere nello
stupro», e che «è per questo che si sente in colpa». Agostino aveva avuto il
buon gusto di aggiungere che, se abbia o meno provato piacere, «ella sola lo
poté sapere». Oppure dobbiamo intendere che la villania di Empson ha la
segreta intenzione di elevare Lucrezia allo status di vera eroina tragica
shakespeariana, agente del suo stesso destino?
Sta di fatto che nel poemetto non ci si decide né per una visione
coerentemente classica, centrata sull’onore pubblico (la «cultura della
vergogna» di cui parla I. Donaldson), né per una visione “cristiana” centrata
sulla coscienza interiore (la «cultura della colpa»). Lucrezia sembra sospesa
tra un punto di vista cripto-agostiniano, e il punto di vista romanamente
fattuale espresso da Bruto, per il quale Lucrezia ha semmai commesso uno
«sbaglio»: quello di ammazzare se stessa invece che Tarquinio. Entrambe le
visioni affiorano a più riprese, e il mixtum, questa volta, risulta torbido e ne
patisce la struttura. Tuttavia, colla sua torbida morbosità, Lucrezia è una
precoce manifestazione di quell’atmosfera di disgusto e repulsione che con
Amleto, Lear e Timone tanta parte avrà nello Shakespeare maturo. Si può
concordare con Prince che il poemetto rivela la «continuità profonda della
sensibilità shakespeariana» ben più di molte altre più piacevoli opere della
sua giovinezza.
«La fenice e la tortora»
Senza titolo, ma sottoscritta «William Shake-speare», la poesia comparve nel
1601 in un libro di Robert Chester, Loves Martyr: Or, Rosalins Complaint ,
«adombrante allegoricamente la fedeltà d’Amore, nel Fato costante della