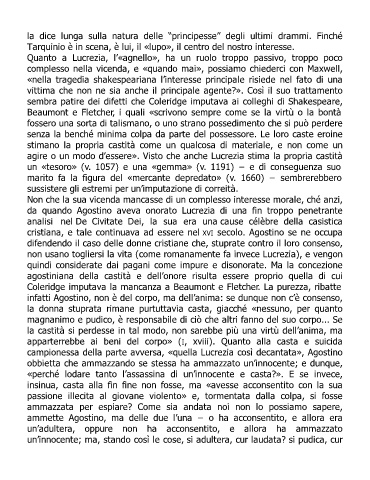Page 2115 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2115
la dice lunga sulla natura delle “principesse” degli ultimi drammi. Finché
Tarquinio è in scena, è lui, il «lupo», il centro del nostro interesse.
Quanto a Lucrezia, l’«agnello», ha un ruolo troppo passivo, troppo poco
complesso nella vicenda, e «quando mai», possiamo chiederci con Maxwell,
«nella tragedia shakespeariana l’interesse principale risiede nel fato di una
vittima che non ne sia anche il principale agente?». Così il suo trattamento
sembra patire dei difetti che Coleridge imputava ai colleghi di Shakespeare,
Beaumont e Fletcher, i quali «scrivono sempre come se la virtù o la bontà
fossero una sorta di talismano, o uno strano possedimento che si può perdere
senza la benché minima colpa da parte del possessore. Le loro caste eroine
stimano la propria castità come un qualcosa di materiale, e non come un
agire o un modo d’essere». Visto che anche Lucrezia stima la propria castità
un «tesoro» (v. 1057) e una «gemma» (v. 1191) − e di conseguenza suo
marito fa la figura del «mercante depredato» (v. 1660) − sembrerebbero
sussistere gli estremi per un’imputazione di correità.
Non che la sua vicenda mancasse di un complesso interesse morale, ché anzi,
da quando Agostino aveva onorato Lucrezia di una fin troppo penetrante
analisi nel De Civitate Dei, la sua era una cause célèbre della casistica
cristiana, e tale continuava ad essere nel XVI secolo. Agostino se ne occupa
difendendo il caso delle donne cristiane che, stuprate contro il loro consenso,
non usano togliersi la vita (come romanamente fa invece Lucrezia), e vengon
quindi considerate dai pagani come impure e disonorate. Ma la concezione
agostiniana della castità e dell’onore risulta essere proprio quella di cui
Coleridge imputava la mancanza a Beaumont e Fletcher. La purezza, ribatte
infatti Agostino, non è del corpo, ma dell’anima: se dunque non c’è consenso,
la donna stuprata rimane purtuttavia casta, giacché «nessuno, per quanto
magnanimo e pudico, è responsabile di ciò che altri fanno del suo corpo... Se
la castità si perdesse in tal modo, non sarebbe più una virtù dell’anima, ma
apparterrebbe ai beni del corpo» (I, xviii). Quanto alla casta e suicida
campionessa della parte avversa, «quella Lucrezia così decantata», Agostino
obbietta che ammazzando se stessa ha ammazzato un’innocente; e dunque,
«perché lodare tanto l’assassina di un’innocente e casta?». E se invece,
insinua, casta alla fin fine non fosse, ma «avesse acconsentito con la sua
passione illecita al giovane violento» e, tormentata dalla colpa, si fosse
ammazzata per espiare? Come sia andata noi non lo possiamo sapere,
ammette Agostino, ma delle due l’una − o ha acconsentito, e allora era
un’adultera, oppure non ha acconsentito, e allora ha ammazzato
un’innocente; ma, stando così le cose, si adultera, cur laudata? si pudica, cur