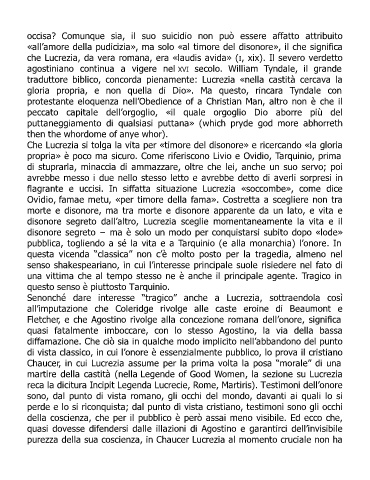Page 2116 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2116
occisa? Comunque sia, il suo suicidio non può essere affatto attribuito
«all’amore della pudicizia», ma solo «al timore del disonore», il che significa
che Lucrezia, da vera romana, era «laudis avida» (I, xix). Il severo verdetto
agostiniano continua a vigere nel XVI secolo. William Tyndale, il grande
traduttore biblico, concorda pienamente: Lucrezia «nella castità cercava la
gloria propria, e non quella di Dio». Ma questo, rincara Tyndale con
protestante eloquenza nell’Obedience of a Christian Man, altro non è che il
peccato capitale dell’orgoglio, «il quale orgoglio Dio aborre più del
puttaneggiamento di qualsiasi puttana» (which pryde god more abhorreth
then the whordome of anye whor).
Che Lucrezia si tolga la vita per «timore del disonore» e ricercando «la gloria
propria» è poco ma sicuro. Come riferiscono Livio e Ovidio, Tarquinio, prima
di stuprarla, minaccia di ammazzare, oltre che lei, anche un suo servo; poi
avrebbe messo i due nello stesso letto e avrebbe detto di averli sorpresi in
flagrante e uccisi. In siffatta situazione Lucrezia «soccombe», come dice
Ovidio, famae metu, «per timore della fama». Costretta a scegliere non tra
morte e disonore, ma tra morte e disonore apparente da un lato, e vita e
disonore segreto dall’altro, Lucrezia sceglie momentaneamente la vita e il
disonore segreto − ma è solo un modo per conquistarsi subito dopo «lode»
pubblica, togliendo a sé la vita e a Tarquinio (e alla monarchia) l’onore. In
questa vicenda “classica” non c’è molto posto per la tragedia, almeno nel
senso shakespeariano, in cui l’interesse principale suole risiedere nel fato di
una vittima che al tempo stesso ne è anche il principale agente. Tragico in
questo senso è piuttosto Tarquinio.
Senonché dare interesse “tragico” anche a Lucrezia, sottraendola così
all’imputazione che Coleridge rivolge alle caste eroine di Beaumont e
Fletcher, e che Agostino rivolge alla concezione romana dell’onore, significa
quasi fatalmente imboccare, con lo stesso Agostino, la via della bassa
diffamazione. Che ciò sia in qualche modo implicito nell’abbandono del punto
di vista classico, in cui l’onore è essenzialmente pubblico, lo prova il cristiano
Chaucer, in cui Lucrezia assume per la prima volta la posa “morale” di una
martire della castità (nella Legende of Good Women, la sezione su Lucrezia
reca la dicitura Incipit Legenda Lucrecie, Rome, Martiris). Testimoni dell’onore
sono, dal punto di vista romano, gli occhi del mondo, davanti ai quali lo si
perde e lo si riconquista; dal punto di vista cristiano, testimoni sono gli occhi
della coscienza, che per il pubblico è però assai meno visibile. Ed ecco che,
quasi dovesse difendersi dalle illazioni di Agostino e garantirci dell’invisibile
purezza della sua coscienza, in Chaucer Lucrezia al momento cruciale non ha