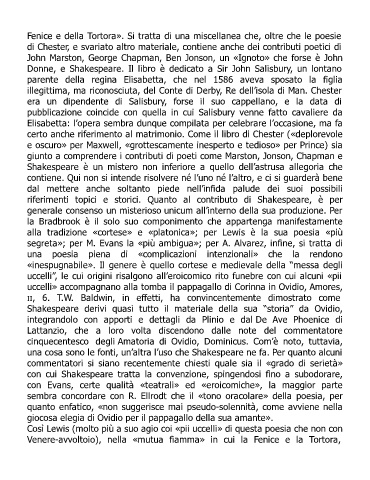Page 2118 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2118
Fenice e della Tortora». Si tratta di una miscellanea che, oltre che le poesie
di Chester, e svariato altro materiale, contiene anche dei contributi poetici di
John Marston, George Chapman, Ben Jonson, un «Ignoto» che forse è John
Donne, e Shakespeare. Il libro è dedicato a Sir John Salisbury, un lontano
parente della regina Elisabetta, che nel 1586 aveva sposato la figlia
illegittima, ma riconosciuta, del Conte di Derby, Re dell’isola di Man. Chester
era un dipendente di Salisbury, forse il suo cappellano, e la data di
pubblicazione coincide con quella in cui Salisbury venne fatto cavaliere da
Elisabetta: l’opera sembra dunque compilata per celebrare l’occasione, ma fa
certo anche riferimento al matrimonio. Come il libro di Chester («deplorevole
e oscuro» per Maxwell, «grottescamente inesperto e tedioso» per Prince) sia
giunto a comprendere i contributi di poeti come Marston, Jonson, Chapman e
Shakespeare è un mistero non inferiore a quello dell’astrusa allegoria che
contiene. Qui non si intende risolvere né l’uno né l’altro, e ci si guarderà bene
dal mettere anche soltanto piede nell’infida palude dei suoi possibili
riferimenti topici e storici. Quanto al contributo di Shakespeare, è per
generale consenso un misterioso unicum all’interno della sua produzione. Per
la Bradbrook è il solo suo componimento che appartenga manifestamente
alla tradizione «cortese» e «platonica»; per Lewis è la sua poesia «più
segreta»; per M. Evans la «più ambigua»; per A. Alvarez, infine, si tratta di
una poesia piena di «complicazioni intenzionali» che la rendono
«inespugnabile». Il genere è quello cortese e medievale della “messa degli
uccelli”, le cui origini risalgono all’eroicomico rito funebre con cui alcuni «pii
uccelli» accompagnano alla tomba il pappagallo di Corinna in Ovidio, Amores,
II, 6. T.W. Baldwin, in effetti, ha convincentemente dimostrato come
Shakespeare derivi quasi tutto il materiale della sua “storia” da Ovidio,
integrandolo con apporti e dettagli da Plinio e dal De Ave Phoenice di
Lattanzio, che a loro volta discendono dalle note del commentatore
cinquecentesco degli Amatoria di Ovidio, Dominicus. Com’è noto, tuttavia,
una cosa sono le fonti, un’altra l’uso che Shakespeare ne fa. Per quanto alcuni
commentatori si siano recentemente chiesti quale sia il «grado di serietà»
con cui Shakespeare tratta la convenzione, spingendosi fino a subodorare,
con Evans, certe qualità «teatrali» ed «eroicomiche», la maggior parte
sembra concordare con R. Ellrodt che il «tono oracolare» della poesia, per
quanto enfatico, «non suggerisce mai pseudo-solennità, come avviene nella
giocosa elegia di Ovidio per il pappagallo della sua amante».
Così Lewis (molto più a suo agio coi «pii uccelli» di questa poesia che non con
Venere-avvoltoio), nella «mutua fiamma» in cui la Fenice e la Tortora,