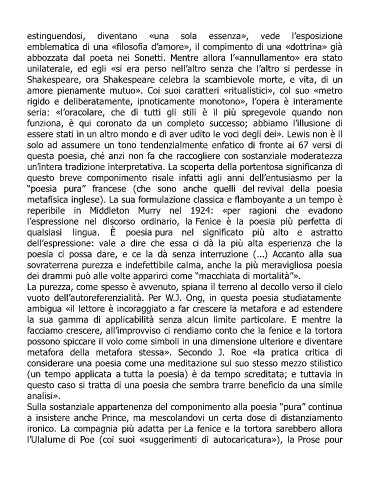Page 2119 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2119
estinguendosi, diventano «una sola essenza», vede l’esposizione
emblematica di una «filosofia d’amore», il compimento di una «dottrina» già
abbozzata dal poeta nei Sonetti. Mentre allora l’«annullamento» era stato
unilaterale, ed egli «si era perso nell’altro senza che l’altro si perdesse in
Shakespeare, ora Shakespeare celebra la scambievole morte, e vita, di un
amore pienamente mutuo». Coi suoi caratteri «ritualistici», col suo «metro
rigido e deliberatamente, ipnoticamente monotono», l’opera è interamente
seria: «l’oracolare, che di tutti gli stili è il più spregevole quando non
funziona, è qui coronato da un completo successo; abbiamo l’illusione di
essere stati in un altro mondo e di aver udito le voci degli dei». Lewis non è il
solo ad assumere un tono tendenzialmente enfatico di fronte ai 67 versi di
questa poesia, ché anzi non fa che raccogliere con sostanziale moderatezza
un’intera tradizione interpretativa. La scoperta della portentosa significanza di
questo breve componimento risale infatti agli anni dell’entusiasmo per la
“poesia pura” francese (che sono anche quelli del revival della poesia
metafisica inglese). La sua formulazione classica e flamboyante a un tempo è
reperibile in Middleton Murry nel 1924: «per ragioni che evadono
l’espressione nel discorso ordinario, la Fenice è la poesia più perfetta di
qualsiasi lingua. È poesia pura nel significato più alto e astratto
dell’espressione: vale a dire che essa ci dà la più alta esperienza che la
poesia ci possa dare, e ce la dà senza interruzione (...) Accanto alla sua
sovraterrena purezza e indefettibile calma, anche la più meravigliosa poesia
dei drammi può alle volte apparirci come “macchiata di mortalità”».
La purezza, come spesso è avvenuto, spiana il terreno al decollo verso il cielo
vuoto dell’autoreferenzialità. Per W.J. Ong, in questa poesia studiatamente
ambigua «il lettore è incoraggiato a far crescere la metafora e ad estendere
la sua gamma di applicabilità senza alcun limite particolare. E mentre la
facciamo crescere, all’improvviso ci rendiamo conto che la fenice e la tortora
possono spiccare il volo come simboli in una dimensione ulteriore e diventare
metafora della metafora stessa». Secondo J. Roe «la pratica critica di
considerare una poesia come una meditazione sul suo stesso mezzo stilistico
(un tempo applicata a tutta la poesia) è da tempo screditata; e tuttavia in
questo caso si tratta di una poesia che sembra trarre beneficio da una simile
analisi».
Sulla sostanziale appartenenza del componimento alla poesia “pura” continua
a insistere anche Prince, ma mescolandovi un certa dose di distanziamento
ironico. La compagnia più adatta per La fenice e la tortora sarebbero allora
l’Ulalume di Poe (coi suoi «suggerimenti di autocaricatura»), la Prose pour