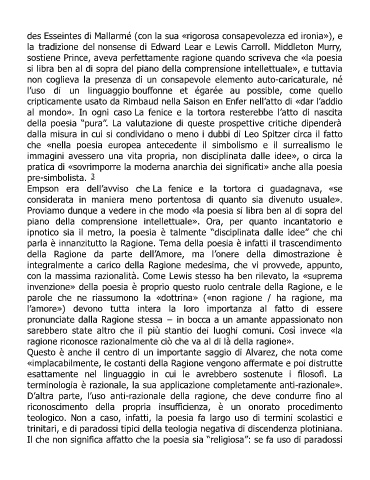Page 2120 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2120
des Esseintes di Mallarmé (con la sua «rigorosa consapevolezza ed ironia»), e
la tradizione del nonsense di Edward Lear e Lewis Carroll. Middleton Murry,
sostiene Prince, aveva perfettamente ragione quando scriveva che «la poesia
si libra ben al di sopra del piano della comprensione intellettuale», e tuttavia
non coglieva la presenza di un consapevole elemento auto-caricaturale, né
l’uso di un linguaggio bouffonne et égarée au possible, come quello
cripticamente usato da Rimbaud nella Saison en Enfer nell’atto di «dar l’addio
al mondo». In ogni caso La fenice e la tortora resterebbe l’atto di nascita
della poesia “pura”. La valutazione di queste prospettive critiche dipenderà
dalla misura in cui si condividano o meno i dubbi di Leo Spitzer circa il fatto
che «nella poesia europea antecedente il simbolismo e il surrealismo le
immagini avessero una vita propria, non disciplinata dalle idee», o circa la
pratica di «sovrimporre la moderna anarchia dei significati» anche alla poesia
pre-simbolista. 3
Empson era dell’avviso che La fenice e la tortora ci guadagnava, «se
considerata in maniera meno portentosa di quanto sia divenuto usuale».
Proviamo dunque a vedere in che modo «la poesia si libra ben al di sopra del
piano della comprensione intellettuale». Ora, per quanto incantatorio e
ipnotico sia il metro, la poesia è talmente “disciplinata dalle idee” che chi
parla è innanzitutto la Ragione. Tema della poesia è infatti il trascendimento
della Ragione da parte dell’Amore, ma l’onere della dimostrazione è
integralmente a carico della Ragione medesima, che vi provvede, appunto,
con la massima razionalità. Come Lewis stesso ha ben rilevato, la «suprema
invenzione» della poesia è proprio questo ruolo centrale della Ragione, e le
parole che ne riassumono la «dottrina» («non ragione / ha ragione, ma
l’amore») devono tutta intera la loro importanza al fatto di essere
pronunciate dalla Ragione stessa − in bocca a un amante appassionato non
sarebbero state altro che il più stantio dei luoghi comuni. Così invece «la
ragione riconosce razionalmente ciò che va al di là della ragione».
Questo è anche il centro di un importante saggio di Alvarez, che nota come
«implacabilmente, le costanti della Ragione vengono affermate e poi distrutte
esattamente nel linguaggio in cui le avrebbero sostenute i filosofi. La
terminologia è razionale, la sua applicazione completamente anti-razionale».
D’altra parte, l’uso anti-razionale della ragione, che deve condurre fino al
riconoscimento della propria insufficienza, è un onorato procedimento
teologico. Non a caso, infatti, la poesia fa largo uso di termini scolastici e
trinitari, e di paradossi tipici della teologia negativa di discendenza plotiniana.
Il che non significa affatto che la poesia sia “religiosa”: se fa uso di paradossi