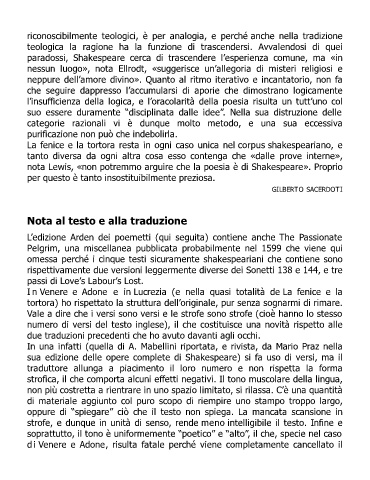Page 2121 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2121
riconoscibilmente teologici, è per analogia, e perché anche nella tradizione
teologica la ragione ha la funzione di trascendersi. Avvalendosi di quei
paradossi, Shakespeare cerca di trascendere l’esperienza comune, ma «in
nessun luogo», nota Ellrodt, «suggerisce un’allegoria di misteri religiosi e
neppure dell’amore divino». Quanto al ritmo iterativo e incantatorio, non fa
che seguire dappresso l’accumularsi di aporie che dimostrano logicamente
l’insufficienza della logica, e l’oracolarità della poesia risulta un tutt’uno col
suo essere duramente “disciplinata dalle idee”. Nella sua distruzione delle
categorie razionali vi è dunque molto metodo, e una sua eccessiva
purificazione non può che indebolirla.
La fenice e la tortora resta in ogni caso unica nel corpus shakespeariano, e
tanto diversa da ogni altra cosa esso contenga che «dalle prove interne»,
nota Lewis, «non potremmo arguire che la poesia è di Shakespeare». Proprio
per questo è tanto insostituibilmente preziosa.
GILBERTO SACERDOTI
Nota al testo e alla traduzione
L’edizione Arden dei poemetti (qui seguita) contiene anche The Passionate
Pelgrim, una miscellanea pubblicata probabilmente nel 1599 che viene qui
omessa perché i cinque testi sicuramente shakespeariani che contiene sono
rispettivamente due versioni leggermente diverse dei Sonetti 138 e 144, e tre
passi di Love’s Labour’s Lost.
I n Venere e Adone e in Lucrezia (e nella quasi totalità de La fenice e la
tortora) ho rispettato la struttura dell’originale, pur senza sognarmi di rimare.
Vale a dire che i versi sono versi e le strofe sono strofe (cioè hanno lo stesso
numero di versi del testo inglese), il che costituisce una novità rispetto alle
due traduzioni precedenti che ho avuto davanti agli occhi.
In una infatti (quella di A. Mabellini riportata, e rivista, da Mario Praz nella
sua edizione delle opere complete di Shakespeare) si fa uso di versi, ma il
traduttore allunga a piacimento il loro numero e non rispetta la forma
strofica, il che comporta alcuni effetti negativi. Il tono muscolare della lingua,
non più costretta a rientrare in uno spazio limitato, si rilassa. C’è una quantità
di materiale aggiunto col puro scopo di riempire uno stampo troppo largo,
oppure di “spiegare” ciò che il testo non spiega. La mancata scansione in
strofe, e dunque in unità di senso, rende meno intelligibile il testo. Infine e
soprattutto, il tono è uniformemente “poetico” e “alto”, il che, specie nel caso
di Venere e Adone, risulta fatale perché viene completamente cancellato il