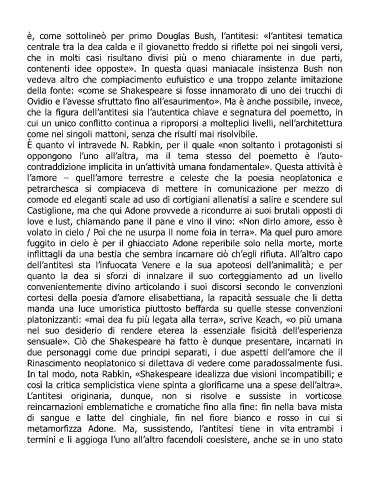Page 2109 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2109
è, come sottolineò per primo Douglas Bush, l’antitesi: «l’antitesi tematica
centrale tra la dea calda e il giovanetto freddo si riflette poi nei singoli versi,
che in molti casi risultano divisi più o meno chiaramente in due parti,
contenenti idee opposte». In questa quasi maniacale insistenza Bush non
vedeva altro che compiacimento eufuistico e una troppo zelante imitazione
della fonte: «come se Shakespeare si fosse innamorato di uno dei trucchi di
Ovidio e l’avesse sfruttato fino all’esaurimento». Ma è anche possibile, invece,
che la figura dell’antitesi sia l’autentica chiave e segnatura del poemetto, in
cui un unico conflitto continua a riproporsi a molteplici livelli, nell’architettura
come nei singoli mattoni, senza che risulti mai risolvibile.
È quanto vi intravede N. Rabkin, per il quale «non soltanto i protagonisti si
oppongono l’uno all’altra, ma il tema stesso del poemetto è l’auto-
contraddizione implicita in un’attività umana fondamentale». Questa attività è
l’amore − quell’amore terrestre e celeste che la poesia neoplatonica e
petrarchesca si compiaceva di mettere in comunicazione per mezzo di
comode ed eleganti scale ad uso di cortigiani allenatisi a salire e scendere sul
Castiglione, ma che qui Adone provvede a ricondurre ai suoi brutali opposti di
love e lust, chiamando pane il pane e vino il vino: «Non dirlo amore, esso è
volato in cielo / Poi che ne usurpa il nome foia in terra». Ma quel puro amore
fuggito in cielo è per il ghiacciato Adone reperibile solo nella morte, morte
inflittagli da una bestia che sembra incarnare ciò ch’egli rifiuta. All’altro capo
dell’antitesi sta l’infuocata Venere e la sua apoteosi dell’animalità; e per
quanto la dea si sforzi di innalzare il suo corteggiamento ad un livello
convenientemente divino articolando i suoi discorsi secondo le convenzioni
cortesi della poesia d’amore elisabettiana, la rapacità sessuale che li detta
manda una luce umoristica piuttosto beffarda su quelle stesse convenzioni
platonizzanti: «mai dea fu più legata alla terra», scrive Keach, «o più umana
nel suo desiderio di rendere eterea la essenziale fisicità dell’esperienza
sensuale». Ciò che Shakespeare ha fatto è dunque presentare, incarnati in
due personaggi come due principi separati, i due aspetti dell’amore che il
Rinascimento neoplatonico si dilettava di vedere come paradossalmente fusi.
In tal modo, nota Rabkin, «Shakespeare idealizza due visioni incompatibili; e
così la critica semplicistica viene spinta a glorificarne una a spese dell’altra».
L’antitesi originaria, dunque, non si risolve e sussiste in vorticose
reincarnazioni emblematiche e cromatiche fino alla fine: fin nella bava mista
di sangue e latte del cinghiale, fin nel fiore bianco e rosso in cui si
metamorfizza Adone. Ma, sussistendo, l’antitesi tiene in vita entrambi i
termini e li aggioga l’uno all’altro facendoli coesistere, anche se in uno stato