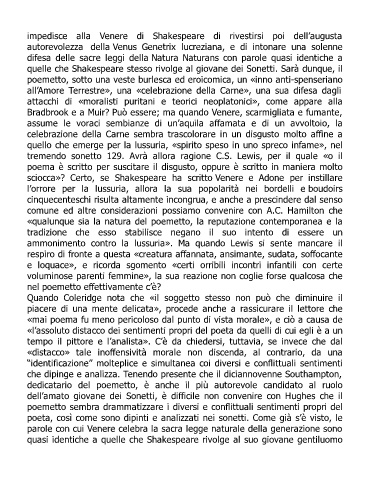Page 2107 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2107
impedisce alla Venere di Shakespeare di rivestirsi poi dell’augusta
autorevolezza della Venus Genetrix lucreziana, e di intonare una solenne
difesa delle sacre leggi della Natura Naturans con parole quasi identiche a
quelle che Shakespeare stesso rivolge al giovane dei Sonetti. Sarà dunque, il
poemetto, sotto una veste burlesca ed eroicomica, un «inno anti-spenseriano
all’Amore Terrestre», una «celebrazione della Carne», una sua difesa dagli
attacchi di «moralisti puritani e teorici neoplatonici», come appare alla
Bradbrook e a Muir? Può essere; ma quando Venere, scarmigliata e fumante,
assume le voraci sembianze di un’aquila affamata e di un avvoltoio, la
celebrazione della Carne sembra trascolorare in un disgusto molto affine a
quello che emerge per la lussuria, «spirito speso in uno spreco infame», nel
tremendo sonetto 129. Avrà allora ragione C.S. Lewis, per il quale «o il
poema è scritto per suscitare il disgusto, oppure è scritto in maniera molto
sciocca»? Certo, se Shakespeare ha scritto Venere e Adone per instillare
l’orrore per la lussuria, allora la sua popolarità nei bordelli e boudoirs
cinquecenteschi risulta altamente incongrua, e anche a prescindere dal senso
comune ed altre considerazioni possiamo convenire con A.C. Hamilton che
«qualunque sia la natura del poemetto, la reputazione contemporanea e la
tradizione che esso stabilisce negano il suo intento di essere un
ammonimento contro la lussuria». Ma quando Lewis si sente mancare il
respiro di fronte a questa «creatura affannata, ansimante, sudata, soffocante
e loquace», e ricorda sgomento «certi orribili incontri infantili con certe
voluminose parenti femmine», la sua reazione non coglie forse qualcosa che
nel poemetto effettivamente c’è?
Quando Coleridge nota che «il soggetto stesso non può che diminuire il
piacere di una mente delicata», procede anche a rassicurare il lettore che
«mai poema fu meno pericoloso dal punto di vista morale», e ciò a causa de
«l’assoluto distacco dei sentimenti propri del poeta da quelli di cui egli è a un
tempo il pittore e l’analista». C’è da chiedersi, tuttavia, se invece che dal
«distacco» tale inoffensività morale non discenda, al contrario, da una
“identificazione” molteplice e simultanea coi diversi e conflittuali sentimenti
che dipinge e analizza. Tenendo presente che il diciannovenne Southampton,
dedicatario del poemetto, è anche il più autorevole candidato al ruolo
dell’amato giovane dei Sonetti, è difficile non convenire con Hughes che il
poemetto sembra drammatizzare i diversi e conflittuali sentimenti propri del
poeta, così come sono dipinti e analizzati nei sonetti. Come già s’è visto, le
parole con cui Venere celebra la sacra legge naturale della generazione sono
quasi identiche a quelle che Shakespeare rivolge al suo giovane gentiluomo