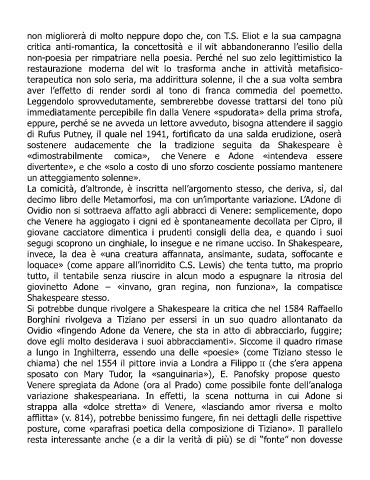Page 2104 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2104
non migliorerà di molto neppure dopo che, con T.S. Eliot e la sua campagna
critica anti-romantica, la concettosità e il wit abbandoneranno l’esilio della
non-poesia per rimpatriare nella poesia. Perché nel suo zelo legittimistico la
restaurazione moderna del wit lo trasforma anche in attività metafisico-
terapeutica non solo seria, ma addirittura solenne, il che a sua volta sembra
aver l’effetto di render sordi al tono di franca commedia del poemetto.
Leggendolo sprovvedutamente, sembrerebbe dovesse trattarsi del tono più
immediatamente percepibile fin dalla Venere «spudorata» della prima strofa,
eppure, perché se ne avveda un lettore avveduto, bisogna attendere il saggio
di Rufus Putney, il quale nel 1941, fortificato da una salda erudizione, oserà
sostenere audacemente che la tradizione seguita da Shakespeare è
«dimostrabilmente comica», che Venere e Adone «intendeva essere
divertente», e che «solo a costo di uno sforzo cosciente possiamo mantenere
un atteggiamento solenne».
La comicità, d’altronde, è inscritta nell’argomento stesso, che deriva, sì, dal
decimo libro delle Metamorfosi, ma con un’importante variazione. L’Adone di
Ovidio non si sottraeva affatto agli abbracci di Venere: semplicemente, dopo
che Venere ha aggiogato i cigni ed è spontaneamente decollata per Cipro, il
giovane cacciatore dimentica i prudenti consigli della dea, e quando i suoi
segugi scoprono un cinghiale, lo insegue e ne rimane ucciso. In Shakespeare,
invece, la dea è «una creatura affannata, ansimante, sudata, soffocante e
loquace» (come appare all’inorridito C.S. Lewis) che tenta tutto, ma proprio
tutto, il tentabile senza riuscire in alcun modo a espugnare la ritrosia del
giovinetto Adone − «invano, gran regina, non funziona», la compatisce
Shakespeare stesso.
Si potrebbe dunque rivolgere a Shakespeare la critica che nel 1584 Raffaello
Borghini rivolgeva a Tiziano per essersi in un suo quadro allontanato da
Ovidio «fingendo Adone da Venere, che sta in atto di abbracciarlo, fuggire;
dove egli molto desiderava i suoi abbracciamenti». Siccome il quadro rimase
a lungo in Inghilterra, essendo una delle «poesie» (come Tiziano stesso le
chiama) che nel 1554 il pittore invia a Londra a Filippo II (che s’era appena
sposato con Mary Tudor, la «sanguinaria»), E. Panofsky propose questo
Venere spregiata da Adone (ora al Prado) come possibile fonte dell’analoga
variazione shakespeariana. In effetti, la scena notturna in cui Adone si
strappa alla «dolce stretta» di Venere, «lasciando amor riversa e molto
afflitta» (v. 814), potrebbe benissimo fungere, fin nei dettagli delle rispettive
posture, come «parafrasi poetica della composizione di Tiziano». Il parallelo
resta interessante anche (e a dir la verità di più) se di “fonte” non dovesse