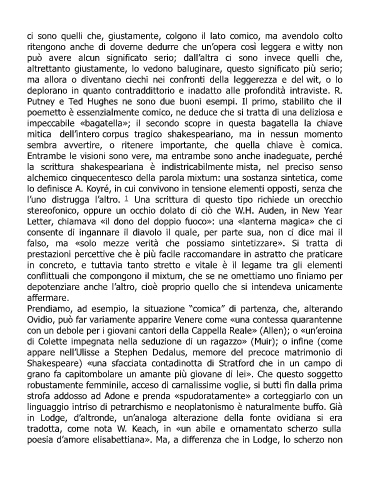Page 2106 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2106
ci sono quelli che, giustamente, colgono il lato comico, ma avendolo colto
ritengono anche di doverne dedurre che un’opera così leggera e witty non
può avere alcun significato serio; dall’altra ci sono invece quelli che,
altrettanto giustamente, lo vedono baluginare, questo significato più serio;
ma allora o diventano ciechi nei confronti della leggerezza e del wit, o lo
deplorano in quanto contraddittorio e inadatto alle profondità intraviste. R.
Putney e Ted Hughes ne sono due buoni esempi. Il primo, stabilito che il
poemetto è essenzialmente comico, ne deduce che si tratta di una deliziosa e
impeccabile «bagatella»; il secondo scopre in questa bagatella la chiave
mitica dell’intero corpus tragico shakespeariano, ma in nessun momento
sembra avvertire, o ritenere importante, che quella chiave è comica.
Entrambe le visioni sono vere, ma entrambe sono anche inadeguate, perché
la scrittura shakespeariana è indistricabilmente mista, nel preciso senso
alchemico cinquecentesco della parola mixtum: una sostanza sintetica, come
lo definisce A. Koyré, in cui convivono in tensione elementi opposti, senza che
1
l’uno distrugga l’altro. Una scrittura di questo tipo richiede un orecchio
stereofonico, oppure un occhio dolato di ciò che W.H. Auden, in New Year
Letter, chiamava «il dono del doppio fuoco»: una «lanterna magica» che ci
consente di ingannare il diavolo il quale, per parte sua, non ci dice mai il
falso, ma «solo mezze verità che possiamo sintetizzare». Si tratta di
prestazioni percettive che è più facile raccomandare in astratto che praticare
in concreto, e tuttavia tanto stretto e vitale è il legame tra gli elementi
conflittuali che compongono il mixtum, che se ne omettiamo uno finiamo per
depotenziare anche l’altro, cioè proprio quello che si intendeva unicamente
affermare.
Prendiamo, ad esempio, la situazione “comica” di partenza, che, alterando
Ovidio, può far variamente apparire Venere come «una contessa quarantenne
con un debole per i giovani cantori della Cappella Reale» (Allen); o «un’eroina
di Colette impegnata nella seduzione di un ragazzo» (Muir); o infine (come
appare nell’Ulisse a Stephen Dedalus, memore del precoce matrimonio di
Shakespeare) «una sfacciata contadinotta di Stratford che in un campo di
grano fa capitombolare un amante più giovane di lei». Che questo soggetto
robustamente femminile, acceso di carnalissime voglie, si butti fin dalla prima
strofa addosso ad Adone e prenda «spudoratamente» a corteggiarlo con un
linguaggio intriso di petrarchismo e neoplatonismo è naturalmente buffo. Già
in Lodge, d’altronde, un’analoga alterazione della fonte ovidiana si era
tradotta, come nota W. Keach, in «un abile e ornamentato scherzo sulla
poesia d’amore elisabettiana». Ma, a differenza che in Lodge, lo scherzo non