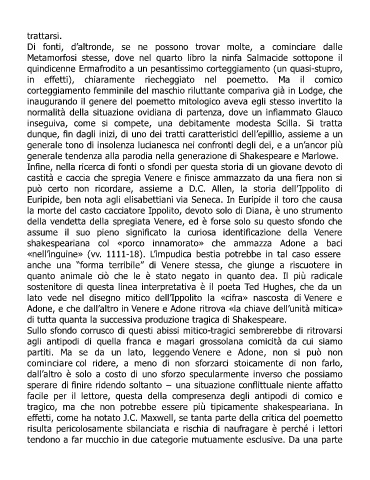Page 2105 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2105
trattarsi.
Di fonti, d’altronde, se ne possono trovar molte, a cominciare dalle
Metamorfosi stesse, dove nel quarto libro la ninfa Salmacide sottopone il
quindicenne Ermafrodito a un pesantissimo corteggiamento (un quasi-stupro,
in effetti), chiaramente riecheggiato nel poemetto. Ma il comico
corteggiamento femminile del maschio riluttante compariva già in Lodge, che
inaugurando il genere del poemetto mitologico aveva egli stesso invertito la
normalità della situazione ovidiana di partenza, dove un infiammato Glauco
inseguiva, come si compete, una debitamente modesta Scilla. Si tratta
dunque, fin dagli inizi, di uno dei tratti caratteristici dell’epillio, assieme a un
generale tono di insolenza lucianesca nei confronti degli dei, e a un’ancor più
generale tendenza alla parodia nella generazione di Shakespeare e Marlowe.
Infine, nella ricerca di fonti o sfondi per questa storia di un giovane devoto di
castità e caccia che spregia Venere e finisce ammazzato da una fiera non si
può certo non ricordare, assieme a D.C. Allen, la storia dell’Ippolito di
Euripide, ben nota agli elisabettiani via Seneca. In Euripide il toro che causa
la morte del casto cacciatore Ippolito, devoto solo di Diana, è uno strumento
della vendetta della spregiata Venere, ed è forse solo su questo sfondo che
assume il suo pieno significato la curiosa identificazione della Venere
shakespeariana col «porco innamorato» che ammazza Adone a baci
«nell’inguine» (vv. 1111-18). L’impudica bestia potrebbe in tal caso essere
anche una “forma terribile” di Venere stessa, che giunge a riscuotere in
quanto animale ciò che le è stato negato in quanto dea. Il più radicale
sostenitore di questa linea interpretativa è il poeta Ted Hughes, che da un
lato vede nel disegno mitico dell’Ippolito la «cifra» nascosta di Venere e
Adone, e che dall’altro in Venere e Adone ritrova «la chiave dell’unità mitica»
di tutta quanta la successiva produzione tragica di Shakespeare.
Sullo sfondo corrusco di questi abissi mitico-tragici sembrerebbe di ritrovarsi
agli antipodi di quella franca e magari grossolana comicità da cui siamo
partiti. Ma se da un lato, leggendo Venere e Adone, non si può non
cominciare col ridere, a meno di non sforzarci stoicamente di non farlo,
dall’altro è solo a costo di uno sforzo specularmente inverso che possiamo
sperare di finire ridendo soltanto − una situazione conflittuale niente affatto
facile per il lettore, questa della compresenza degli antipodi di comico e
tragico, ma che non potrebbe essere più tipicamente shakespeariana. In
effetti, come ha notato J.C. Maxwell, se tanta parte della critica del poemetto
risulta pericolosamente sbilanciata e rischia di naufragare è perché i lettori
tendono a far mucchio in due categorie mutuamente esclusive. Da una parte