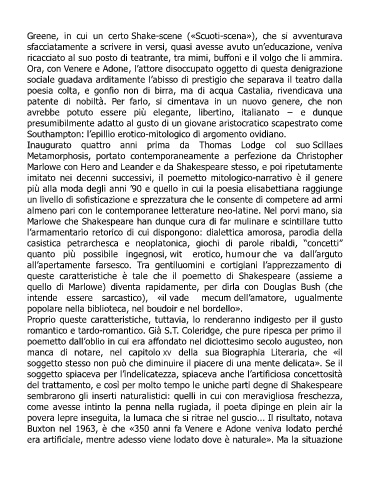Page 2103 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2103
Greene, in cui un certo Shake-scene («Scuoti-scena»), che si avventurava
sfacciatamente a scrivere in versi, quasi avesse avuto un’educazione, veniva
ricacciato al suo posto di teatrante, tra mimi, buffoni e il volgo che li ammira.
Ora, con Venere e Adone, l’attore disoccupato oggetto di questa denigrazione
sociale guadava arditamente l’abisso di prestigio che separava il teatro dalla
poesia colta, e gonfio non di birra, ma di acqua Castalia, rivendicava una
patente di nobiltà. Per farlo, si cimentava in un nuovo genere, che non
avrebbe potuto essere più elegante, libertino, italianato − e dunque
presumibilmente adatto al gusto di un giovane aristocratico scapestrato come
Southampton: l’epillio erotico-mitologico di argomento ovidiano.
Inaugurato quattro anni prima da Thomas Lodge col suo Scillaes
Metamorphosis, portato contemporaneamente a perfezione da Christopher
Marlowe con Hero and Leander e da Shakespeare stesso, e poi ripetutamente
imitato nei decenni successivi, il poemetto mitologico-narrativo è il genere
più alla moda degli anni ’90 e quello in cui la poesia elisabettiana raggiunge
un livello di sofisticazione e sprezzatura che le consente di competere ad armi
almeno pari con le contemporanee letterature neo-latine. Nel porvi mano, sia
Marlowe che Shakespeare han dunque cura di far mulinare e scintillare tutto
l’armamentario retorico di cui dispongono: dialettica amorosa, parodia della
casistica petrarchesca e neoplatonica, giochi di parole ribaldi, “concetti”
quanto più possibile ingegnosi, wit erotico, humour che va dall’arguto
all’apertamente farsesco. Tra gentiluomini e cortigiani l’apprezzamento di
queste caratteristiche è tale che il poemetto di Shakespeare (assieme a
quello di Marlowe) diventa rapidamente, per dirla con Douglas Bush (che
intende essere sarcastico), «il vade mecum dell’amatore, ugualmente
popolare nella biblioteca, nel boudoir e nel bordello».
Proprio queste caratteristiche, tuttavia, lo renderanno indigesto per il gusto
romantico e tardo-romantico. Già S.T. Coleridge, che pure ripesca per primo il
poemetto dall’oblio in cui era affondato nel diciottesimo secolo augusteo, non
manca di notare, nel capitolo XV della sua Biographia Literaria, che «il
soggetto stesso non può che diminuire il piacere di una mente delicata». Se il
soggetto spiaceva per l’indelicatezza, spiaceva anche l’artificiosa concettosità
del trattamento, e così per molto tempo le uniche parti degne di Shakespeare
sembrarono gli inserti naturalistici: quelli in cui con meravigliosa freschezza,
come avesse intinto la penna nella rugiada, il poeta dipinge en plein air la
povera lepre inseguita, la lumaca che si ritrae nel guscio... Il risultato, notava
Buxton nel 1963, è che «350 anni fa Venere e Adone veniva lodato perché
era artificiale, mentre adesso viene lodato dove è naturale». Ma la situazione