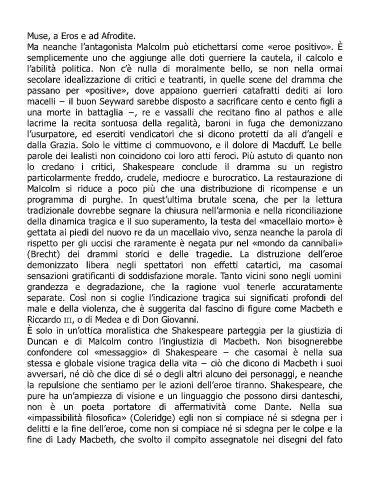Page 1945 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1945
Muse, a Eros e ad Afrodite.
Ma neanche l’antagonista Malcolm può etichettarsi come «eroe positivo». È
semplicemente uno che aggiunge alle doti guerriere la cautela, il calcolo e
l’abilità politica. Non c’è nulla di moralmente bello, se non nella ormai
secolare idealizzazione di critici e teatranti, in quelle scene del dramma che
passano per «positive», dove appaiono guerrieri catafratti dediti ai loro
macelli − il buon Seyward sarebbe disposto a sacrificare cento e cento figli a
una morte in battaglia −, re e vassalli che recitano fino al pathos e alle
lacrime la recita sontuosa della regalità, baroni in fuga che demonizzano
l’usurpatore, ed eserciti vendicatori che si dicono protetti da ali d’angeli e
dalla Grazia. Solo le vittime ci commuovono, e il dolore di Macduff. Le belle
parole dei lealisti non coincidono coi loro atti feroci. Più astuto di quanto non
lo credano i critici, Shakespeare conclude il dramma su un registro
particolarmente freddo, crudele, mediocre e burocratico. La restaurazione di
Malcolm si riduce a poco più che una distribuzione di ricompense e un
programma di purghe. In quest’ultima brutale scena, che per la lettura
tradizionale dovrebbe segnare la chiusura nell’armonia e nella riconciliazione
della dinamica tragica e il suo superamento, la testa del «macellaio morto» è
gettata ai piedi del nuovo re da un macellaio vivo, senza neanche la parola di
rispetto per gli uccisi che raramente è negata pur nel «mondo da cannibali»
(Brecht) dei drammi storici e delle tragedie. La distruzione dell’eroe
demonizzato libera negli spettatori non effetti catartici, ma casomai
sensazioni gratificanti di soddisfazione morale. Tanto vicini sono negli uomini
grandezza e degradazione, che la ragione vuol tenerle accuratamente
separate. Così non si coglie l’indicazione tragica sui significati profondi del
male e della violenza, che è suggerita dal fascino di figure come Macbeth e
Riccardo III, o di Medea e di Don Giovanni.
È solo in un’ottica moralistica che Shakespeare parteggia per la giustizia di
Duncan e di Malcolm contro l’ingiustizia di Macbeth. Non bisognerebbe
confondere col «messaggio» di Shakespeare − che casomai è nella sua
stessa e globale visione tragica della vita − ciò che dicono di Macbeth i suoi
avversari, né ciò che dice di sé o degli altri alcuno dei personaggi, e neanche
la repulsione che sentiamo per le azioni dell’eroe tiranno. Shakespeare, che
pure ha un’ampiezza di visione e un linguaggio che possono dirsi danteschi,
non è un poeta portatore di affermatività come Dante. Nella sua
«impassibilità filosofica» (Coleridge) egli non si compiace né si sdegna per i
delitti e la fine dell’eroe, come non si compiace né si sdegna per le colpe e la
fine di Lady Macbeth, che svolto il compito assegnatole nei disegni del fato