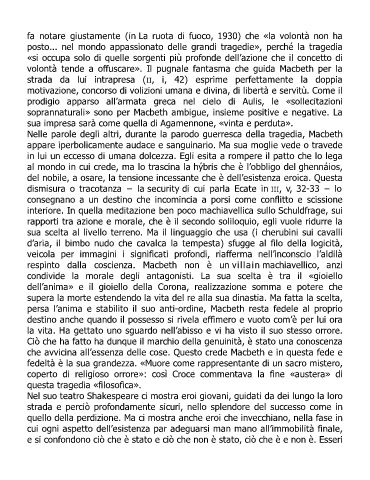Page 1943 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1943
fa notare giustamente (in La ruota di fuoco, 1930) che «la volontà non ha
posto... nel mondo appassionato delle grandi tragedie», perché la tragedia
«si occupa solo di quelle sorgenti più profonde dell’azione che il concetto di
volontà tende a offuscare». Il pugnale fantasma che guida Macbeth per la
strada da lui intrapresa (II, i, 42) esprime perfettamente la doppia
motivazione, concorso di volizioni umana e divina, di libertà e servitù. Come il
prodigio apparso all’armata greca nel cielo di Aulis, le «sollecitazioni
soprannaturali» sono per Macbeth ambigue, insieme positive e negative. La
sua impresa sarà come quella di Agamennone, «vinta e perduta».
Nelle parole degli altri, durante la parodo guerresca della tragedia, Macbeth
appare iperbolicamente audace e sanguinario. Ma sua moglie vede o travede
in lui un eccesso di umana dolcezza. Egli esita a rompere il patto che lo lega
al mondo in cui crede, ma lo trascina la hýbris che è l’obbligo del ghennáios,
del nobile, a osare, la tensione incessante che è dell’esistenza eroica. Questa
dismisura o tracotanza − la security di cui parla Ecate in III, v, 32-33 − lo
consegnano a un destino che incomincia a porsi come conflitto e scissione
interiore. In quella meditazione ben poco machiavellica sullo Schuldfrage, sui
rapporti tra azione e morale, che è il secondo soliloquio, egli vuole ridurre la
sua scelta al livello terreno. Ma il linguaggio che usa (i cherubini sui cavalli
d’aria, il bimbo nudo che cavalca la tempesta) sfugge al filo della logicità,
veicola per immagini i significati profondi, riafferma nell’inconscio l’aldilà
respinto dalla coscienza. Macbeth non è un villain machiavellico, anzi
condivide la morale degli antagonisti. La sua scelta è tra il «gioiello
dell’anima» e il gioiello della Corona, realizzazione somma e potere che
supera la morte estendendo la vita del re alla sua dinastia. Ma fatta la scelta,
persa l’anima e stabilito il suo anti-ordine, Macbeth resta fedele al proprio
destino anche quando il possesso si rivela effimero e vuoto com’è per lui ora
la vita. Ha gettato uno sguardo nell’abisso e vi ha visto il suo stesso orrore.
Ciò che ha fatto ha dunque il marchio della genuinità, è stato una conoscenza
che avvicina all’essenza delle cose. Questo crede Macbeth e in questa fede e
fedeltà è la sua grandezza. «Muore come rappresentante di un sacro mistero,
coperto di religioso orrore»: così Croce commentava la fine «austera» di
questa tragedia «filosofica».
Nel suo teatro Shakespeare ci mostra eroi giovani, guidati da dei lungo la loro
strada e perciò profondamente sicuri, nello splendore del successo come in
quello della perdizione. Ma ci mostra anche eroi che invecchiano, nella fase in
cui ogni aspetto dell’esistenza par adeguarsi man mano all’immobilità finale,
e si confondono ciò che è stato e ciò che non è stato, ciò che è e non è. Esseri