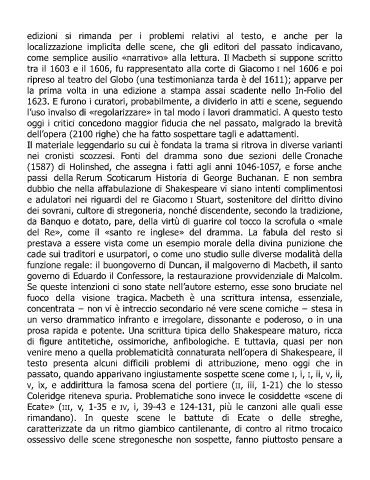Page 1947 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1947
edizioni si rimanda per i problemi relativi al testo, e anche per la
localizzazione implicita delle scene, che gli editori del passato indicavano,
come semplice ausilio «narrativo» alla lettura. Il Macbeth si suppone scritto
tra il 1603 e il 1606, fu rappresentato alla corte di Giacomo I nel 1606 e poi
ripreso al teatro del Globo (una testimonianza tarda è del 1611); apparve per
la prima volta in una edizione a stampa assai scadente nello In-Folio del
1623. E furono i curatori, probabilmente, a dividerlo in atti e scene, seguendo
l’uso invalso di «regolarizzare» in tal modo i lavori drammatici. A questo testo
oggi i critici concedono maggior fiducia che nel passato, malgrado la brevità
dell’opera (2100 righe) che ha fatto sospettare tagli e adattamenti.
Il materiale leggendario su cui è fondata la trama si ritrova in diverse varianti
nei cronisti scozzesi. Fonti del dramma sono due sezioni delle Cronache
(1587) di Holinshed, che assegna i fatti agli anni 1046-1057, e forse anche
passi della Rerum Scoticarum Historia di George Buchanan. E non sembra
dubbio che nella affabulazione di Shakespeare vi siano intenti complimentosi
e adulatori nei riguardi del re Giacomo I Stuart, sostenitore del diritto divino
dei sovrani, cultore di stregoneria, nonché discendente, secondo la tradizione,
da Banquo e dotato, pare, della virtù di guarire col tocco la scrofula o «male
del Re», come il «santo re inglese» del dramma. La fabula del resto si
prestava a essere vista come un esempio morale della divina punizione che
cade sui traditori e usurpatori, o come uno studio sulle diverse modalità della
funzione regale: il buongoverno di Duncan, il malgoverno di Macbeth, il santo
governo di Eduardo il Confessore, la restaurazione provvidenziale di Malcolm.
Se queste intenzioni ci sono state nell’autore esterno, esse sono bruciate nel
fuoco della visione tragica. Macbeth è una scrittura intensa, essenziale,
concentrata − non vi è intreccio secondario né vere scene comiche − stesa in
un verso drammatico infranto e irregolare, dissonante e poderoso, o in una
prosa rapida e potente. Una scrittura tipica dello Shakespeare maturo, ricca
di figure antitetiche, ossimoriche, anfibologiche. E tuttavia, quasi per non
venire meno a quella problematicità connaturata nell’opera di Shakespeare, il
testo presenta alcuni difficili problemi di attribuzione, meno oggi che in
passato, quando apparivano ingiustamente sospette scene come I, i, I, ii, V, ii,
V, ix, e addirittura la famosa scena del portiere (II, iii, 1-21) che lo stesso
Coleridge riteneva spuria. Problematiche sono invece le cosiddette «scene di
Ecate» (III, v, 1-35 e IV, i, 39-43 e 124-131, più le canzoni alle quali esse
rimandano). In queste scene le battute di Ecate o delle streghe,
caratterizzate da un ritmo giambico cantilenante, di contro al ritmo trocaico
ossessivo delle scene stregonesche non sospette, fanno piuttosto pensare a