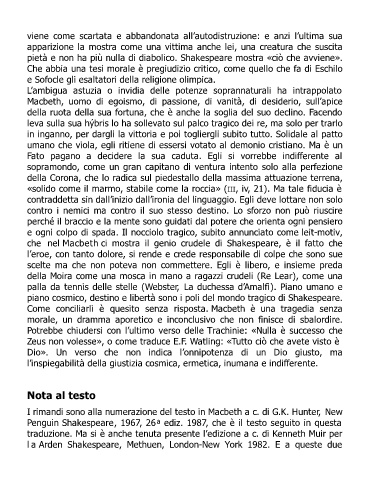Page 1946 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1946
viene come scartata e abbandonata all’autodistruzione: e anzi l’ultima sua
apparizione la mostra come una vittima anche lei, una creatura che suscita
pietà e non ha più nulla di diabolico. Shakespeare mostra «ciò che avviene».
Che abbia una tesi morale è pregiudizio critico, come quello che fa di Eschilo
e Sofocle gli esaltatori della religione olimpica.
L’ambigua astuzia o invidia delle potenze soprannaturali ha intrappolato
Macbeth, uomo di egoismo, di passione, di vanità, di desiderio, sull’apice
della ruota della sua fortuna, che è anche la soglia del suo declino. Facendo
leva sulla sua hýbris lo ha sollevato sul palco tragico dei re, ma solo per trarlo
in inganno, per dargli la vittoria e poi togliergli subito tutto. Solidale al patto
umano che viola, egli ritiene di essersi votato al demonio cristiano. Ma è un
Fato pagano a decidere la sua caduta. Egli si vorrebbe indifferente al
sopramondo, come un gran capitano di ventura intento solo alla perfezione
della Corona, che lo radica sul piedestallo della massima attuazione terrena,
«solido come il marmo, stabile come la roccia» (III, iv, 21). Ma tale fiducia è
contraddetta sin dall’inizio dall’ironia del linguaggio. Egli deve lottare non solo
contro i nemici ma contro il suo stesso destino. Lo sforzo non può riuscire
perché il braccio e la mente sono guidati dal potere che orienta ogni pensiero
e ogni colpo di spada. Il nocciolo tragico, subito annunciato come leit-motiv,
che nel Macbeth ci mostra il genio crudele di Shakespeare, è il fatto che
l’eroe, con tanto dolore, si rende e crede responsabile di colpe che sono sue
scelte ma che non poteva non commettere. Egli è libero, e insieme preda
della Moira come una mosca in mano a ragazzi crudeli (Re Lear), come una
palla da tennis delle stelle (Webster, La duchessa d’Amalfi). Piano umano e
piano cosmico, destino e libertà sono i poli del mondo tragico di Shakespeare.
Come conciliarli è quesito senza risposta. Macbeth è una tragedia senza
morale, un dramma aporetico e inconclusivo che non finisce di sbalordire.
Potrebbe chiudersi con l’ultimo verso delle Trachinie: «Nulla è successo che
Zeus non volesse», o come traduce E.F. Watling: «Tutto ciò che avete visto è
Dio». Un verso che non indica l’onnipotenza di un Dio giusto, ma
l’inspiegabilità della giustizia cosmica, ermetica, inumana e indifferente.
Nota al testo
I rimandi sono alla numerazione del testo in Macbeth a c. di G.K. Hunter, New
a
Penguin Shakespeare, 1967, 26 ediz. 1987, che è il testo seguito in questa
traduzione. Ma si è anche tenuta presente l’edizione a c. di Kenneth Muir per
l a Arden Shakespeare, Methuen, London-New York 1982. E a queste due