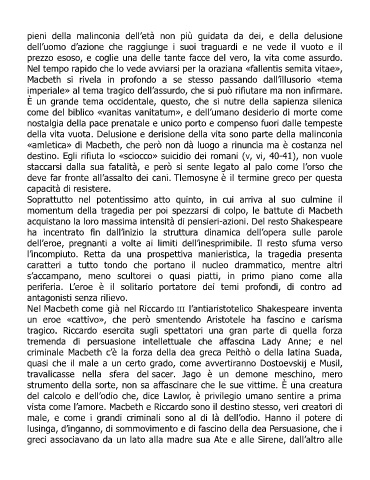Page 1944 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1944
pieni della malinconia dell’età non più guidata da dei, e della delusione
dell’uomo d’azione che raggiunge i suoi traguardi e ne vede il vuoto e il
prezzo esoso, e coglie una delle tante facce del vero, la vita come assurdo.
Nel tempo rapido che lo vede avviarsi per la oraziana «fallentis semita vitae»,
Macbeth si rivela in profondo a se stesso passando dall’illusorio «tema
imperiale» al tema tragico dell’assurdo, che si può rifiutare ma non infirmare.
È un grande tema occidentale, questo, che si nutre della sapienza silenica
come del biblico «vanitas vanitatum», e dell’umano desiderio di morte come
nostalgia della pace prenatale e unico porto e compenso fuori dalle tempeste
della vita vuota. Delusione e derisione della vita sono parte della malinconia
«amletica» di Macbeth, che però non dà luogo a rinuncia ma è costanza nel
destino. Egli rifiuta lo «sciocco» suicidio dei romani (V, vi, 40-41), non vuole
staccarsi dalla sua fatalità, e però si sente legato al palo come l’orso che
deve far fronte all’assalto dei cani. Tlemosyne è il termine greco per questa
capacità di resistere.
Soprattutto nel potentissimo atto quinto, in cui arriva al suo culmine il
momentum della tragedia per poi spezzarsi di colpo, le battute di Macbeth
acquistano la loro massima intensità di pensieri-azioni. Del resto Shakespeare
ha incentrato fin dall’inizio la struttura dinamica dell’opera sulle parole
dell’eroe, pregnanti a volte ai limiti dell’inesprimibile. Il resto sfuma verso
l’incompiuto. Retta da una prospettiva manieristica, la tragedia presenta
caratteri a tutto tondo che portano il nucleo drammatico, mentre altri
s’accampano, meno scultorei o quasi piatti, in primo piano come alla
periferia. L’eroe è il solitario portatore dei temi profondi, di contro ad
antagonisti senza rilievo.
Nel Macbeth come già nel Riccardo III l’antiaristotelico Shakespeare inventa
un eroe «cattivo», che però smentendo Aristotele ha fascino e carisma
tragico. Riccardo esercita sugli spettatori una gran parte di quella forza
tremenda di persuasione intellettuale che affascina Lady Anne; e nel
criminale Macbeth c’è la forza della dea greca Peithò o della latina Suada,
quasi che il male a un certo grado, come avvertiranno Dostoevskij e Musil,
travalicasse nella sfera del sacer. Jago è un demone meschino, mero
strumento della sorte, non sa affascinare che le sue vittime. È una creatura
del calcolo e dell’odio che, dice Lawlor, è privilegio umano sentire a prima
vista come l’amore. Macbeth e Riccardo sono il destino stesso, veri creatori di
male, e come i grandi criminali sono al di là dell’odio. Hanno il potere di
lusinga, d’inganno, di sommovimento e di fascino della dea Persuasione, che i
greci associavano da un lato alla madre sua Ate e alle Sirene, dall’altro alle