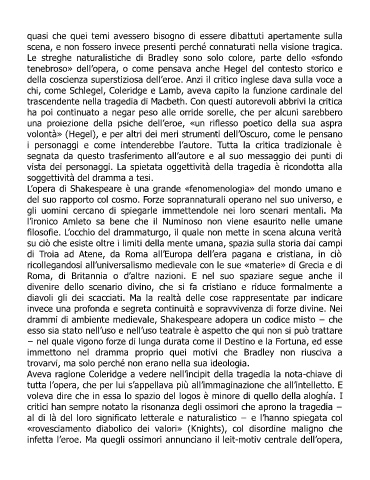Page 1941 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1941
quasi che quei temi avessero bisogno di essere dibattuti apertamente sulla
scena, e non fossero invece presenti perché connaturati nella visione tragica.
Le streghe naturalistiche di Bradley sono solo colore, parte dello «sfondo
tenebroso» dell’opera, o come pensava anche Hegel del contesto storico e
della coscienza superstiziosa dell’eroe. Anzi il critico inglese dava sulla voce a
chi, come Schlegel, Coleridge e Lamb, aveva capito la funzione cardinale del
trascendente nella tragedia di Macbeth. Con questi autorevoli abbrivi la critica
ha poi continuato a negar peso alle orride sorelle, che per alcuni sarebbero
una proiezione della psiche dell’eroe, «un riflesso poetico della sua aspra
volontà» (Hegel), e per altri dei meri strumenti dell’Oscuro, come le pensano
i personaggi e come intenderebbe l’autore. Tutta la critica tradizionale è
segnata da questo trasferimento all’autore e al suo messaggio dei punti di
vista dei personaggi. La spietata oggettività della tragedia è ricondotta alla
soggettività del dramma a tesi.
L’opera di Shakespeare è una grande «fenomenologia» del mondo umano e
del suo rapporto col cosmo. Forze soprannaturali operano nel suo universo, e
gli uomini cercano di spiegarle immettendole nei loro scenari mentali. Ma
l’ironico Amleto sa bene che il Numinoso non viene esaurito nelle umane
filosofie. L’occhio del drammaturgo, il quale non mette in scena alcuna verità
su ciò che esiste oltre i limiti della mente umana, spazia sulla storia dai campi
di Troia ad Atene, da Roma all’Europa dell’era pagana e cristiana, in ciò
ricollegandosi all’universalismo medievale con le sue «materie» di Grecia e di
Roma, di Britannia o d’altre nazioni. E nel suo spaziare segue anche il
divenire dello scenario divino, che si fa cristiano e riduce formalmente a
diavoli gli dei scacciati. Ma la realtà delle cose rappresentate par indicare
invece una profonda e segreta continuità e sopravvivenza di forze divine. Nei
drammi di ambiente medievale, Shakespeare adopera un codice misto − che
esso sia stato nell’uso e nell’uso teatrale è aspetto che qui non si può trattare
− nel quale vigono forze di lunga durata come il Destino e la Fortuna, ed esse
immettono nel dramma proprio quei motivi che Bradley non riusciva a
trovarvi, ma solo perché non erano nella sua ideologia.
Aveva ragione Coleridge a vedere nell’incipit della tragedia la nota-chiave di
tutta l’opera, che per lui s’appellava più all’immaginazione che all’intelletto. E
voleva dire che in essa lo spazio del logos è minore di quello della aloghía. I
critici han sempre notato la risonanza degli ossimori che aprono la tragedia −
al di là del loro significato letterale e naturalistico − e l’hanno spiegata col
«rovesciamento diabolico dei valori» (Knights), col disordine maligno che
infetta l’eroe. Ma quegli ossimori annunciano il leit-motiv centrale dell’opera,