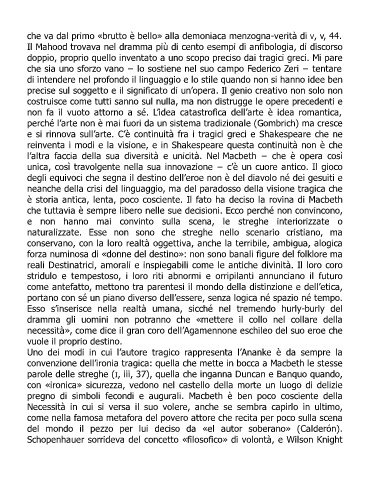Page 1942 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1942
che va dal primo «brutto è bello» alla demoniaca menzogna-verità di V, v, 44.
Il Mahood trovava nel dramma più di cento esempi di anfibologia, di discorso
doppio, proprio quello inventato a uno scopo preciso dai tragici greci. Mi pare
che sia uno sforzo vano − lo sostiene nel suo campo Federico Zeri − tentare
di intendere nel profondo il linguaggio e lo stile quando non si hanno idee ben
precise sul soggetto e il significato di un’opera. Il genio creativo non solo non
costruisce come tutti sanno sul nulla, ma non distrugge le opere precedenti e
non fa il vuoto attorno a sé. L’idea catastrofica dell’arte è idea romantica,
perché l’arte non è mai fuori da un sistema tradizionale (Gombrich) ma cresce
e si rinnova sull’arte. C’è continuità fra i tragici greci e Shakespeare che ne
reinventa i modi e la visione, e in Shakespeare questa continuità non è che
l’altra faccia della sua diversità e unicità. Nel Macbeth − che è opera così
unica, così travolgente nella sua innovazione − c’è un cuore antico. Il gioco
degli equivoci che segna il destino dell’eroe non è del diavolo né dei gesuiti e
neanche della crisi del linguaggio, ma del paradosso della visione tragica che
è storia antica, lenta, poco cosciente. Il fato ha deciso la rovina di Macbeth
che tuttavia è sempre libero nelle sue decisioni. Ecco perché non convincono,
e non hanno mai convinto sulla scena, le streghe interiorizzate o
naturalizzate. Esse non sono che streghe nello scenario cristiano, ma
conservano, con la loro realtà oggettiva, anche la terribile, ambigua, alogica
forza numinosa di «donne del destino»: non sono banali figure del folklore ma
reali Destinatrici, amorali e inspiegabili come le antiche divinità. Il loro coro
stridulo e tempestoso, i loro riti abnormi e orripilanti annunciano il futuro
come antefatto, mettono tra parentesi il mondo della distinzione e dell’etica,
portano con sé un piano diverso dell’essere, senza logica né spazio né tempo.
Esso s’inserisce nella realtà umana, sicché nel tremendo hurly-burly del
dramma gli uomini non potranno che «mettere il collo nel collare della
necessità», come dice il gran coro dell’Agamennone eschileo del suo eroe che
vuole il proprio destino.
Uno dei modi in cui l’autore tragico rappresenta l’Ananke è da sempre la
convenzione dell’ironia tragica: quella che mette in bocca a Macbeth le stesse
parole delle streghe (I, iii, 37), quella che inganna Duncan e Banquo quando,
con «ironica» sicurezza, vedono nel castello della morte un luogo di delizie
pregno di simboli fecondi e augurali. Macbeth è ben poco cosciente della
Necessità in cui si versa il suo volere, anche se sembra capirlo in ultimo,
come nella famosa metafora del povero attore che recita per poco sulla scena
del mondo il pezzo per lui deciso da «el autor soberano» (Calderón).
Schopenhauer sorrideva del concetto «filosofico» di volontà, e Wilson Knight