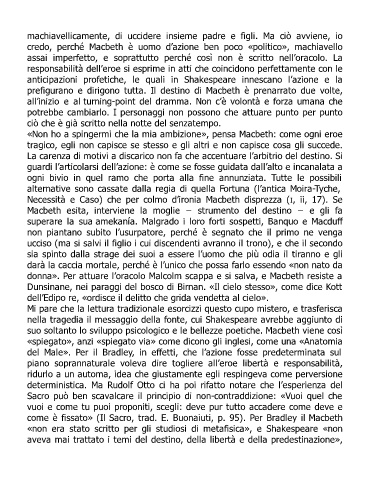Page 1940 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1940
machiavellicamente, di uccidere insieme padre e figli. Ma ciò avviene, io
credo, perché Macbeth è uomo d’azione ben poco «politico», machiavello
assai imperfetto, e soprattutto perché così non è scritto nell’oracolo. La
responsabilità dell’eroe si esprime in atti che coincidono perfettamente con le
anticipazioni profetiche, le quali in Shakespeare innescano l’azione e la
prefigurano e dirigono tutta. Il destino di Macbeth è prenarrato due volte,
all’inizio e al turning-point del dramma. Non c’è volontà e forza umana che
potrebbe cambiarlo. I personaggi non possono che attuare punto per punto
ciò che è già scritto nella notte del senzatempo.
«Non ho a spingermi che la mia ambizione», pensa Macbeth: come ogni eroe
tragico, egli non capisce se stesso e gli altri e non capisce cosa gli succede.
La carenza di motivi a discarico non fa che accentuare l’arbitrio del destino. Si
guardi l’articolarsi dell’azione: è come se fosse guidata dall’alto e incanalata a
ogni bivio in quel ramo che porta alla fine annunziata. Tutte le possibili
alternative sono cassate dalla regia di quella Fortuna (l’antica Moira-Tyche,
Necessità e Caso) che per colmo d’ironia Macbeth disprezza (I, ii, 17). Se
Macbeth esita, interviene la moglie − strumento del destino − e gli fa
superare la sua amekanía. Malgrado i loro forti sospetti, Banquo e Macduff
non piantano subito l’usurpatore, perché è segnato che il primo ne venga
ucciso (ma si salvi il figlio i cui discendenti avranno il trono), e che il secondo
sia spinto dalla strage dei suoi a essere l’uomo che più odia il tiranno e gli
darà la caccia mortale, perché è l’unico che possa farlo essendo «non nato da
donna». Per attuare l’oracolo Malcolm scappa e si salva, e Macbeth resiste a
Dunsinane, nei paraggi del bosco di Birnan. «Il cielo stesso», come dice Kott
dell’Edipo re, «ordisce il delitto che grida vendetta al cielo».
Mi pare che la lettura tradizionale esorcizzi questo cupo mistero, e trasferisca
nella tragedia il messaggio della fonte, cui Shakespeare avrebbe aggiunto di
suo soltanto lo sviluppo psicologico e le bellezze poetiche. Macbeth viene così
«spiegato», anzi «spiegato via» come dicono gli inglesi, come una «Anatomia
del Male». Per il Bradley, in effetti, che l’azione fosse predeterminata sul
piano soprannaturale voleva dire togliere all’eroe libertà e responsabilità,
ridurlo a un automa, idea che giustamente egli respingeva come perversione
deterministica. Ma Rudolf Otto ci ha poi rifatto notare che l’esperienza del
Sacro può ben scavalcare il principio di non-contraddizione: «Vuoi quel che
vuoi e come tu puoi proponiti, scegli: deve pur tutto accadere come deve e
come è fissato» (Il Sacro, trad. E. Buonaiuti, p. 95). Per Bradley il Macbeth
«non era stato scritto per gli studiosi di metafisica», e Shakespeare «non
aveva mai trattato i temi del destino, della libertà e della predestinazione»,