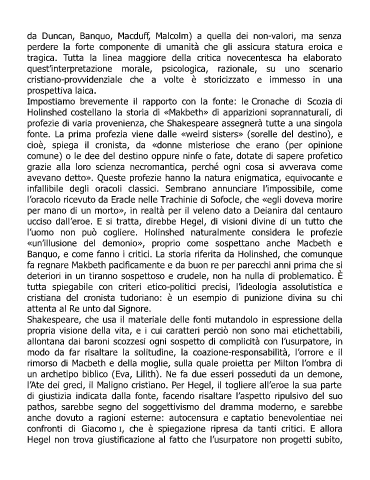Page 1939 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1939
da Duncan, Banquo, Macduff, Malcolm) a quella dei non-valori, ma senza
perdere la forte componente di umanità che gli assicura statura eroica e
tragica. Tutta la linea maggiore della critica novecentesca ha elaborato
quest’interpretazione morale, psicologica, razionale, su uno scenario
cristiano-provvidenziale che a volte è storicizzato e immesso in una
prospettiva laica.
Impostiamo brevemente il rapporto con la fonte: le Cronache di Scozia di
Holinshed costellano la storia di «Makbeth» di apparizioni soprannaturali, di
profezie di varia provenienza, che Shakespeare assegnerà tutte a una singola
fonte. La prima profezia viene dalle «weird sisters» (sorelle del destino), e
cioè, spiega il cronista, da «donne misteriose che erano (per opinione
comune) o le dee del destino oppure ninfe o fate, dotate di sapere profetico
grazie alla loro scienza necromantica, perché ogni cosa si avverava come
avevano detto». Queste profezie hanno la natura enigmatica, equivocante e
infallibile degli oracoli classici. Sembrano annunciare l’impossibile, come
l’oracolo ricevuto da Eracle nelle Trachinie di Sofocle, che «egli doveva morire
per mano di un morto», in realtà per il veleno dato a Deianira dal centauro
ucciso dall’eroe. E si tratta, direbbe Hegel, di visioni divine di un tutto che
l’uomo non può cogliere. Holinshed naturalmente considera le profezie
«un’illusione del demonio», proprio come sospettano anche Macbeth e
Banquo, e come fanno i critici. La storia riferita da Holinshed, che comunque
fa regnare Makbeth pacificamente e da buon re per parecchi anni prima che si
deteriori in un tiranno sospettoso e crudele, non ha nulla di problematico. È
tutta spiegabile con criteri etico-politici precisi, l’ideologia assolutistica e
cristiana del cronista tudoriano: è un esempio di punizione divina su chi
attenta al Re unto dal Signore.
Shakespeare, che usa il materiale delle fonti mutandolo in espressione della
propria visione della vita, e i cui caratteri perciò non sono mai etichettabili,
allontana dai baroni scozzesi ogni sospetto di complicità con l’usurpatore, in
modo da far risaltare la solitudine, la coazione-responsabilità, l’orrore e il
rimorso di Macbeth e della moglie, sulla quale proietta per Milton l’ombra di
un archetipo biblico (Eva, Lilith). Ne fa due esseri posseduti da un demone,
l’Ate dei greci, il Maligno cristiano. Per Hegel, il togliere all’eroe la sua parte
di giustizia indicata dalla fonte, facendo risaltare l’aspetto ripulsivo del suo
pathos, sarebbe segno del soggettivismo del dramma moderno, e sarebbe
anche dovuto a ragioni esterne: autocensura e captatio benevolentiae nei
confronti di Giacomo I, che è spiegazione ripresa da tanti critici. E allora
Hegel non trova giustificazione al fatto che l’usurpatore non progetti subito,