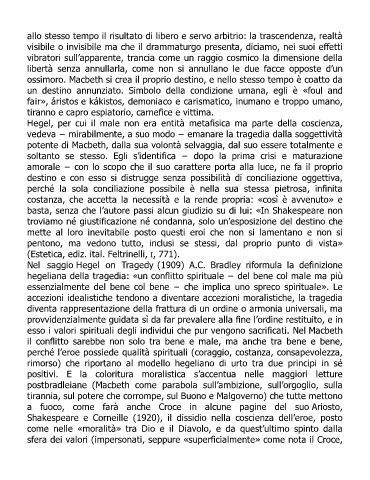Page 1938 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1938
allo stesso tempo il risultato di libero e servo arbitrio: la trascendenza, realtà
visibile o invisibile ma che il drammaturgo presenta, diciamo, nei suoi effetti
vibratori sull’apparente, trancia come un raggio cosmico la dimensione della
libertà senza annullarla, come non si annullano le due facce opposte d’un
ossimoro. Macbeth si crea il proprio destino, e nello stesso tempo è coatto da
un destino annunziato. Simbolo della condizione umana, egli è «foul and
fair», áristos e kákistos, demoniaco e carismatico, inumano e troppo umano,
tiranno e capro espiatorio, carnefice e vittima.
Hegel, per cui il male non era entità metafisica ma parte della coscienza,
vedeva − mirabilmente, a suo modo − emanare la tragedia dalla soggettività
potente di Macbeth, dalla sua volontà selvaggia, dal suo essere totalmente e
soltanto se stesso. Egli s’identifica − dopo la prima crisi e maturazione
amorale − con lo scopo che il suo carattere porta alla luce, ne fa il proprio
destino e con esso si distrugge senza possibilità di conciliazione oggettiva,
perché la sola conciliazione possibile è nella sua stessa pietrosa, infinita
costanza, che accetta la necessità e la rende propria: «così è avvenuto» e
basta, senza che l’autore passi alcun giudizio su di lui: «In Shakespeare non
troviamo né giustificazione né condanna, solo un’esposizione del destino che
mette al loro inevitabile posto questi eroi che non si lamentano e non si
pentono, ma vedono tutto, inclusi se stessi, dal proprio punto di vista»
(Estetica, ediz. ital. Feltrinelli, I, 771).
Nel saggio Hegel on Tragedy (1909) A.C. Bradley riformula la definizione
hegeliana della tragedia: «un conflitto spirituale − del bene col male ma più
essenzialmente del bene col bene − che implica uno spreco spirituale». Le
accezioni idealistiche tendono a diventare accezioni moralistiche, la tragedia
diventa rappresentazione della frattura di un ordine o armonia universali, ma
provvidenzialmente guidata sì da far prevalere alla fine l’ordine restituito, e in
esso i valori spirituali degli individui che pur vengono sacrificati. Nel Macbeth
il conflitto sarebbe non solo tra bene e male, ma anche tra bene e bene,
perché l’eroe possiede qualità spirituali (coraggio, costanza, consapevolezza,
rimorso) che riportano al modello hegeliano di urto tra due principi in sé
positivi. E la coloritura moralistica s’accentua nelle maggiori letture
postbradleiane (Macbeth come parabola sull’ambizione, sull’orgoglio, sulla
tirannia, sul potere che corrompe, sul Buono e Malgoverno) che tutte mettono
a fuoco, come farà anche Croce in alcune pagine del suo Ariosto,
Shakespeare e Corneille (1920), il dissidio nella coscienza dell’eroe, posto
come nelle «moralità» tra Dio e il Diavolo, e da quest’ultimo spinto dalla
sfera dei valori (impersonati, seppure «superficialmente» come nota il Croce,