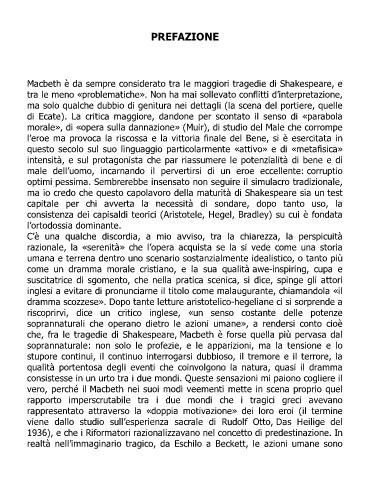Page 1937 - Shakespeare - Vol. 3
P. 1937
PREFAZIONE
Macbeth è da sempre considerato tra le maggiori tragedie di Shakespeare, e
tra le meno «problematiche». Non ha mai sollevato conflitti d’interpretazione,
ma solo qualche dubbio di genitura nei dettagli (la scena del portiere, quelle
di Ecate). La critica maggiore, dandone per scontato il senso di «parabola
morale», di «opera sulla dannazione» (Muir), di studio del Male che corrompe
l’eroe ma provoca la riscossa e la vittoria finale del Bene, si è esercitata in
questo secolo sul suo linguaggio particolarmente «attivo» e di «metafisica»
intensità, e sul protagonista che par riassumere le potenzialità di bene e di
male dell’uomo, incarnando il pervertirsi di un eroe eccellente: corruptio
optimi pessima. Sembrerebbe insensato non seguire il simulacro tradizionale,
ma io credo che questo capolavoro della maturità di Shakespeare sia un test
capitale per chi avverta la necessità di sondare, dopo tanto uso, la
consistenza dei capisaldi teorici (Aristotele, Hegel, Bradley) su cui è fondata
l’ortodossia dominante.
C’è una qualche discordia, a mio avviso, tra la chiarezza, la perspicuità
razionale, la «serenità» che l’opera acquista se la si vede come una storia
umana e terrena dentro uno scenario sostanzialmente idealistico, o tanto più
come un dramma morale cristiano, e la sua qualità awe-inspiring, cupa e
suscitatrice di sgomento, che nella pratica scenica, si dice, spinge gli attori
inglesi a evitare di pronunciarne il titolo come malaugurante, chiamandola «il
dramma scozzese». Dopo tante letture aristotelico-hegeliane ci si sorprende a
riscoprirvi, dice un critico inglese, «un senso costante delle potenze
soprannaturali che operano dietro le azioni umane», a rendersi conto cioè
che, fra le tragedie di Shakespeare, Macbeth è forse quella più pervasa dal
soprannaturale: non solo le profezie, e le apparizioni, ma la tensione e lo
stupore continui, il continuo interrogarsi dubbioso, il tremore e il terrore, la
qualità portentosa degli eventi che coinvolgono la natura, quasi il dramma
consistesse in un urto tra i due mondi. Queste sensazioni mi paiono cogliere il
vero, perché il Macbeth nei suoi modi veementi mette in scena proprio quel
rapporto imperscrutabile tra i due mondi che i tragici greci avevano
rappresentato attraverso la «doppia motivazione» dei loro eroi (il termine
viene dallo studio sull’esperienza sacrale di Rudolf Otto, Das Heilige del
1936), e che i Riformatori razionalizzavano nel concetto di predestinazione. In
realtà nell’immaginario tragico, da Eschilo a Beckett, le azioni umane sono