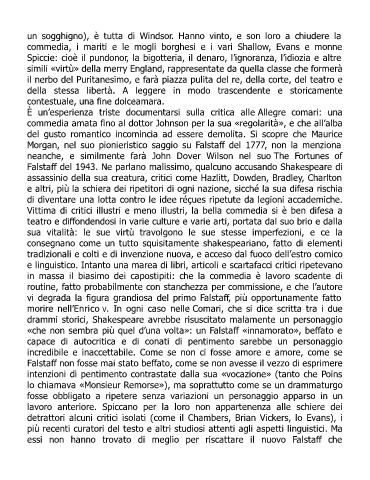Page 2302 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2302
un sogghigno), è tutta di Windsor. Hanno vinto, e son loro a chiudere la
commedia, i mariti e le mogli borghesi e i vari Shallow, Evans e monne
Spiccie: cioè il pundonor, la bigotteria, il denaro, l’ignoranza, l’idiozia e altre
simili «virtù» della merry England, rappresentate da quella classe che formerà
il nerbo del Puritanesimo, e farà piazza pulita del re, della corte, del teatro e
della stessa libertà. A leggere in modo trascendente e storicamente
contestuale, una fine dolceamara.
È un’esperienza triste documentarsi sulla critica alle Allegre comari: una
commedia amata fino al dottor Johnson per la sua «regolarità», e che all’alba
del gusto romantico incomincia ad essere demolita. Si scopre che Maurice
Morgan, nel suo pionieristico saggio su Falstaff del 1777, non la menziona
neanche, e similmente farà John Dover Wilson nel suo The Fortunes of
Falstaff del 1943. Ne parlano malissimo, qualcuno accusando Shakespeare di
assassinio della sua creatura, critici come Hazlitt, Dowden, Bradley, Charlton
e altri, più la schiera dei ripetitori di ogni nazione, sicché la sua difesa rischia
di diventare una lotta contro le idee réçues ripetute da legioni accademiche.
Vittima di critici illustri e meno illustri, la bella commedia si è ben difesa a
teatro e diffondendosi in varie culture e varie arti, portata dal suo brio e dalla
sua vitalità: le sue virtù travolgono le sue stesse imperfezioni, e ce la
consegnano come un tutto squisitamente shakespeariano, fatto di elementi
tradizionali e colti e di invenzione nuova, e acceso dal fuoco dell’estro comico
e linguistico. Intanto una marea di libri, articoli e scartafacci critici ripetevano
in massa il biasimo dei capostipiti: che la commedia è lavoro scadente di
routine, fatto probabilmente con stanchezza per commissione, e che l’autore
vi degrada la figura grandiosa del primo Falstaff, più opportunamente fatto
morire nell’Enrico V. In ogni caso nelle Comari, che si dice scritta tra i due
drammi storici, Shakespeare avrebbe risuscitato malamente un personaggio
«che non sembra più quel d’una volta»: un Falstaff «innamorato», beffato e
capace di autocritica e di conati di pentimento sarebbe un personaggio
incredibile e inaccettabile. Come se non ci fosse amore e amore, come se
Falstaff non fosse mai stato beffato, come se non avesse il vezzo di esprimere
intenzioni di pentimento contrastate dalla sua «vocazione» (tanto che Poins
lo chiamava «Monsieur Remorse»), ma soprattutto come se un drammaturgo
fosse obbligato a ripetere senza variazioni un personaggio apparso in un
lavoro anteriore. Spiccano per la loro non appartenenza alle schiere dei
detrattori alcuni critici isolati (come il Chambers, Brian Vickers, lo Evans), i
più recenti curatori del testo e altri studiosi attenti agli aspetti linguistici. Ma
essi non hanno trovato di meglio per riscattare il nuovo Falstaff che