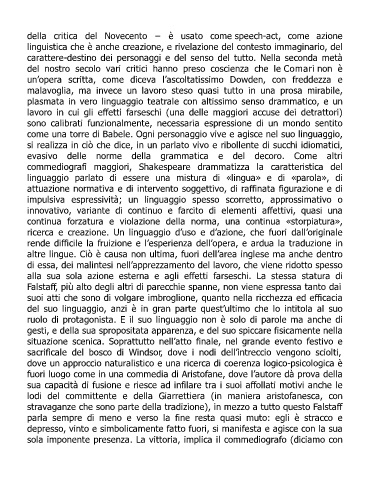Page 2301 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2301
della critica del Novecento − è usato come speech-act, come azione
linguistica che è anche creazione, e rivelazione del contesto immaginario, del
carattere-destino dei personaggi e del senso del tutto. Nella seconda metà
del nostro secolo vari critici hanno preso coscienza che le Comari non è
un’opera scritta, come diceva l’ascoltatissimo Dowden, con freddezza e
malavoglia, ma invece un lavoro steso quasi tutto in una prosa mirabile,
plasmata in vero linguaggio teatrale con altissimo senso drammatico, e un
lavoro in cui gli effetti farseschi (una delle maggiori accuse dei detrattori)
sono calibrati funzionalmente, necessaria espressione di un mondo sentito
come una torre di Babele. Ogni personaggio vive e agisce nel suo linguaggio,
si realizza in ciò che dice, in un parlato vivo e ribollente di succhi idiomatici,
evasivo delle norme della grammatica e del decoro. Come altri
commediografi maggiori, Shakespeare drammatizza la caratteristica del
linguaggio parlato di essere una mistura di «lingua» e di «parola», di
attuazione normativa e di intervento soggettivo, di raffinata figurazione e di
impulsiva espressività; un linguaggio spesso scorretto, approssimativo o
innovativo, variante di continuo e farcito di elementi affettivi, quasi una
continua forzatura e violazione della norma, una continua «storpiatura»,
ricerca e creazione. Un linguaggio d’uso e d’azione, che fuori dall’originale
rende difficile la fruizione e l’esperienza dell’opera, e ardua la traduzione in
altre lingue. Ciò è causa non ultima, fuori dell’area inglese ma anche dentro
di essa, dei malintesi nell’apprezzamento del lavoro, che viene ridotto spesso
alla sua sola azione esterna e agli effetti farseschi. La stessa statura di
Falstaff, più alto degli altri di parecchie spanne, non viene espressa tanto dai
suoi atti che sono di volgare imbroglione, quanto nella ricchezza ed efficacia
del suo linguaggio, anzi è in gran parte quest’ultimo che lo intitola al suo
ruolo di protagonista. E il suo linguaggio non è solo di parole ma anche di
gesti, e della sua spropositata apparenza, e del suo spiccare fisicamente nella
situazione scenica. Soprattutto nell’atto finale, nel grande evento festivo e
sacrificale del bosco di Windsor, dove i nodi dell’intreccio vengono sciolti,
dove un approccio naturalistico e una ricerca di coerenza logico-psicologica è
fuori luogo come in una commedia di Aristofane, dove l’autore dà prova della
sua capacità di fusione e riesce ad infilare tra i suoi affollati motivi anche le
lodi del committente e della Giarrettiera (in maniera aristofanesca, con
stravaganze che sono parte della tradizione), in mezzo a tutto questo Falstaff
parla sempre di meno e verso la fine resta quasi muto: egli è stracco e
depresso, vinto e simbolicamente fatto fuori, si manifesta e agisce con la sua
sola imponente presenza. La vittoria, implica il commediografo (diciamo con