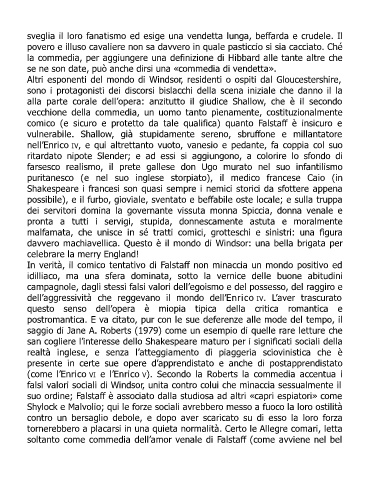Page 2299 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2299
sveglia il loro fanatismo ed esige una vendetta lunga, beffarda e crudele. Il
povero e illuso cavaliere non sa davvero in quale pasticcio si sia cacciato. Ché
la commedia, per aggiungere una definizione di Hibbard alle tante altre che
se ne son date, può anche dirsi una «commedia di vendetta».
Altri esponenti del mondo di Windsor, residenti o ospiti dal Gloucestershire,
sono i protagonisti dei discorsi bislacchi della scena iniziale che danno il la
alla parte corale dell’opera: anzitutto il giudice Shallow, che è il secondo
vecchione della commedia, un uomo tanto pienamente, costituzionalmente
comico (e sicuro e protetto da tale qualifica) quanto Falstaff è insicuro e
vulnerabile. Shallow, già stupidamente sereno, sbruffone e millantatore
nell’Enrico IV, e qui altrettanto vuoto, vanesio e pedante, fa coppia col suo
ritardato nipote Slender; e ad essi si aggiungono, a colorire lo sfondo di
farsesco realismo, il prete gallese don Ugo murato nel suo infantilismo
puritanesco (e nel suo inglese storpiato), il medico francese Caio (in
Shakespeare i francesi son quasi sempre i nemici storici da sfottere appena
possibile), e il furbo, gioviale, sventato e beffabile oste locale; e sulla truppa
dei servitori domina la governante vissuta monna Spiccia, donna venale e
pronta a tutti i servigi, stupida, donnescamente astuta e moralmente
malfamata, che unisce in sé tratti comici, grotteschi e sinistri: una figura
davvero machiavellica. Questo è il mondo di Windsor: una bella brigata per
celebrare la merry England!
In verità, il comico tentativo di Falstaff non minaccia un mondo positivo ed
idilliaco, ma una sfera dominata, sotto la vernice delle buone abitudini
campagnole, dagli stessi falsi valori dell’egoismo e del possesso, del raggiro e
dell’aggressività che reggevano il mondo dell’Enrico IV. L’aver trascurato
questo senso dell’opera è miopia tipica della critica romantica e
postromantica. E va citato, pur con le sue deferenze alle mode del tempo, il
saggio di Jane A. Roberts (1979) come un esempio di quelle rare letture che
san cogliere l’interesse dello Shakespeare maturo per i significati sociali della
realtà inglese, e senza l’atteggiamento di piaggeria sciovinistica che è
presente in certe sue opere d’apprendistato e anche di postapprendistato
(come l’Enrico VI e l’Enrico V). Secondo la Roberts la commedia accentua i
falsi valori sociali di Windsor, unita contro colui che minaccia sessualmente il
suo ordine; Falstaff è associato dalla studiosa ad altri «capri espiatori» come
Shylock e Malvolio; qui le forze sociali avrebbero messo a fuoco la loro ostilità
contro un bersaglio debole, e dopo aver scaricato su di esso la loro forza
tornerebbero a placarsi in una quieta normalità. Certo le Allegre comari, letta
soltanto come commedia dell’amor venale di Falstaff (come avviene nel bel