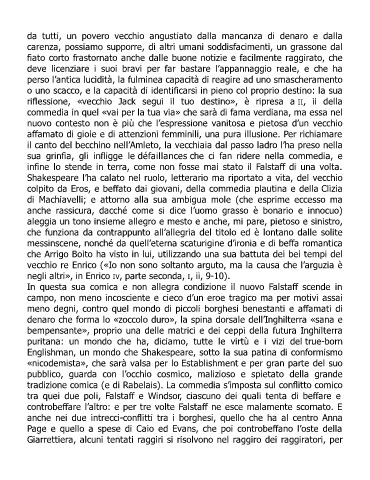Page 2297 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2297
da tutti, un povero vecchio angustiato dalla mancanza di denaro e dalla
carenza, possiamo supporre, di altri umani soddisfacimenti, un grassone dal
fiato corto frastornato anche dalle buone notizie e facilmente raggirato, che
deve licenziare i suoi bravi per far bastare l’appannaggio reale, e che ha
perso l’antica lucidità, la fulminea capacità di reagire ad uno smascheramento
o uno scacco, e la capacità di identificarsi in pieno col proprio destino: la sua
riflessione, «vecchio Jack segui il tuo destino», è ripresa a II, ii della
commedia in quel «vai per la tua via» che sarà di fama verdiana, ma essa nel
nuovo contesto non è più che l’espressione vanitosa e pietosa d’un vecchio
affamato di gioie e di attenzioni femminili, una pura illusione. Per richiamare
il canto del becchino nell’Amleto, la vecchiaia dal passo ladro l’ha preso nella
sua grinfia, gli infligge le défaillances che ci fan ridere nella commedia, e
infine lo stende in terra, come non fosse mai stato il Falstaff di una volta.
Shakespeare l’ha calato nel ruolo, letterario ma riportato a vita, del vecchio
colpito da Eros, e beffato dai giovani, della commedia plautina e della Clizia
di Machiavelli; e attorno alla sua ambigua mole (che esprime eccesso ma
anche rassicura, dacché come si dice l’uomo grasso è bonario e innocuo)
aleggia un tono insieme allegro e mesto e anche, mi pare, pietoso e sinistro,
che funziona da contrappunto all’allegria del titolo ed è lontano dalle solite
messinscene, nonché da quell’eterna scaturigine d’ironia e di beffa romantica
che Arrigo Boito ha visto in lui, utilizzando una sua battuta dei bei tempi del
vecchio re Enrico («Io non sono soltanto arguto, ma la causa che l’arguzia è
negli altri», in Enrico IV, parte seconda, I, ii, 9-10).
In questa sua comica e non allegra condizione il nuovo Falstaff scende in
campo, non meno incosciente e cieco d’un eroe tragico ma per motivi assai
meno degni, contro quel mondo di piccoli borghesi benestanti e affamati di
denaro che forma lo «zoccolo duro», la spina dorsale dell’Inghilterra «sana e
bempensante», proprio una delle matrici e dei ceppi della futura Inghilterra
puritana: un mondo che ha, diciamo, tutte le virtù e i vizi del true-born
Englishman, un mondo che Shakespeare, sotto la sua patina di conformismo
«nicodemista», che sarà valsa per lo Establishment e per gran parte del suo
pubblico, guarda con l’occhio cosmico, malizioso e spietato della grande
tradizione comica (e di Rabelais). La commedia s’imposta sul conflitto comico
tra quei due poli, Falstaff e Windsor, ciascuno dei quali tenta di beffare e
controbeffare l’altro: e per tre volte Falstaff ne esce malamente scornato. E
anche nei due intrecci-conflitti tra i borghesi, quello che ha al centro Anna
Page e quello a spese di Caio ed Evans, che poi controbeffano l’oste della
Giarrettiera, alcuni tentati raggiri si risolvono nel raggiro dei raggiratori, per