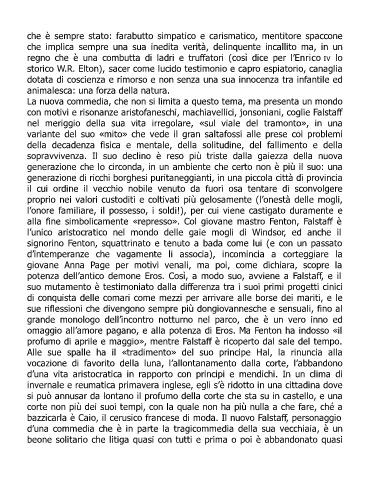Page 2296 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2296
che è sempre stato: farabutto simpatico e carismatico, mentitore spaccone
che implica sempre una sua inedita verità, delinquente incallito ma, in un
regno che è una combutta di ladri e truffatori (così dice per l’Enrico IV lo
storico W.R. Elton), sacer come lucido testimonio e capro espiatorio, canaglia
dotata di coscienza e rimorso e non senza una sua innocenza tra infantile ed
animalesca: una forza della natura.
La nuova commedia, che non si limita a questo tema, ma presenta un mondo
con motivi e risonanze aristofaneschi, machiavellici, jonsoniani, coglie Falstaff
nel meriggio della sua vita irregolare, «sul viale del tramonto», in una
variante del suo «mito» che vede il gran saltafossi alle prese coi problemi
della decadenza fisica e mentale, della solitudine, del fallimento e della
sopravvivenza. Il suo declino è reso più triste dalla gaiezza della nuova
generazione che lo circonda, in un ambiente che certo non è più il suo: una
generazione di ricchi borghesi puritaneggianti, in una piccola città di provincia
il cui ordine il vecchio nobile venuto da fuori osa tentare di sconvolgere
proprio nei valori custoditi e coltivati più gelosamente (l’onestà delle mogli,
l’onore familiare, il possesso, i soldi!), per cui viene castigato duramente e
alla fine simbolicamente «represso». Col giovane mastro Fenton, Falstaff è
l’unico aristocratico nel mondo delle gaie mogli di Windsor, ed anche il
signorino Fenton, squattrinato e tenuto a bada come lui (e con un passato
d’intemperanze che vagamente li associa), incomincia a corteggiare la
giovane Anna Page per motivi venali, ma poi, come dichiara, scopre la
potenza dell’antico demone Eros. Così, a modo suo, avviene a Falstaff, e il
suo mutamento è testimoniato dalla differenza tra i suoi primi progetti cinici
di conquista delle comari come mezzi per arrivare alle borse dei mariti, e le
sue riflessioni che divengono sempre più dongiovannesche e sensuali, fino al
grande monologo dell’incontro notturno nel parco, che è un vero inno ed
omaggio all’amore pagano, e alla potenza di Eros. Ma Fenton ha indosso «il
profumo di aprile e maggio», mentre Falstaff è ricoperto dal sale del tempo.
Alle sue spalle ha il «tradimento» del suo principe Hal, la rinuncia alla
vocazione di favorito della luna, l’allontanamento dalla corte, l’abbandono
d’una vita aristocratica in rapporto con principi e mendichi. In un clima di
invernale e reumatica primavera inglese, egli s’è ridotto in una cittadina dove
si può annusar da lontano il profumo della corte che sta su in castello, e una
corte non più dei suoi tempi, con la quale non ha più nulla a che fare, ché a
bazzicarla è Caio, il cerusico francese di moda. Il nuovo Falstaff, personaggio
d’una commedia che è in parte la tragicommedia della sua vecchiaia, è un
beone solitario che litiga quasi con tutti e prima o poi è abbandonato quasi