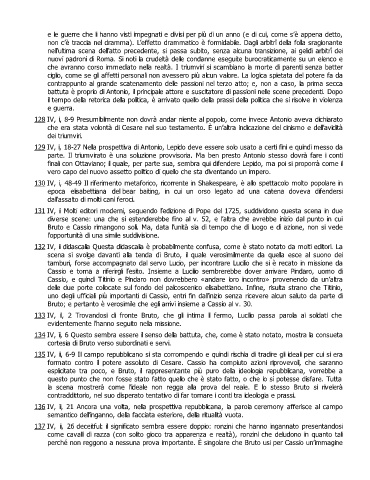Page 2288 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2288
e le guerre che li hanno visti impegnati e divisi per più di un anno (e di cui, come s’è appena detto,
non c’è traccia nel dramma). L’effetto drammatico è formidabile. Dagli arbitrî della folla sragionante
nell’ultima scena dell’atto precedente, si passa subito, senza alcuna transizione, ai gelidi arbitrî dei
nuovi padroni di Roma. Si noti la crudeltà delle condanne eseguite burocraticamente su un elenco e
che avranno corso immediato nella realtà. I triumviri si scambiano la morte di parenti senza batter
ciglio, come se gli affetti personali non avessero più alcun valore. La logica spietata del potere fa da
contrappunto al grande scatenamento delle passioni nel terzo atto; e, non a caso, la prima secca
battuta è proprio di Antonio, il principale attore e suscitatore di passioni nelle scene precedenti. Dopo
il tempo della retorica della politica, è arrivato quello della prassi della politica che si risolve in violenza
e guerra.
128 IV, i, 8-9 Presumibilmente non dovrà andar niente al popolo, come invece Antonio aveva dichiarato
che era stata volontà di Cesare nel suo testamento. È un’altra indicazione del cinismo e dell’avidità
dei triumviri.
129 IV, i, 18-27 Nella prospettiva di Antonio, Lepido deve essere solo usato a certi fini e quindi messo da
parte. Il triumvirato è una soluzione provvisoria. Ma ben presto Antonio stesso dovrà fare i conti
finali con Ottaviano; il quale, per parte sua, sembra qui difendere Lepido, ma poi si proporrà come il
vero capo del nuovo assetto politico di quello che sta diventando un impero.
130 IV, i, 48-49 Il riferimento metaforico, ricorrente in Shakespeare, è allo spettacolo molto popolare in
epoca elisabettiana del bear baiting, in cui un orso legato ad una catena doveva difendersi
dall’assalto di molti cani feroci.
131 IV, ii Molti editori moderni, seguendo l’edizione di Pope del 1725, suddividono questa scena in due
diverse scene: una che si estenderebbe fino al v. 52, e l’altra che avrebbe inizio dal punto in cui
Bruto e Cassio rimangono soli. Ma, data l’unità sia di tempo che di luogo e di azione, non si vede
l’opportunità di una simile suddivisione.
132 IV, ii didascalia Questa didascalia è probabilmente confusa, come è stato notato da molti editori. La
scena si svolge davanti alla tenda di Bruto, il quale verosimilmente da quella esce al suono dei
tamburi, forse accompagnato dal servo Lucio, per incontrare Lucilio che si è recato in missione da
Cassio e torna a riferirgli l’esito. Insieme a Lucilio sembrerebbe dover arrivare Pindaro, uomo di
Cassio, e quindi Titinio e Pindaro non dovrebbero «andare loro incontro» provenendo da un’altra
delle due porte collocate sul fondo del palcoscenico elisabettiano. Infine, risulta strano che Titinio,
uno degli ufficiali più importanti di Cassio, entri fin dall’inizio senza ricevere alcun saluto da parte di
Bruto; e pertanto è verosimile che egli arrivi insieme a Cassio al v. 30.
133 IV, ii, 2 Trovandosi di fronte Bruto, che gli intima il fermo, Lucilio passa parola ai soldati che
evidentemente l’hanno seguito nella missione.
134 IV, ii, 6 Questo sembra essere il senso della battuta, che, come è stato notato, mostra la consueta
cortesia di Bruto verso subordinati e servi.
135 IV, ii, 6-9 Il campo repubblicano si sta corrompendo e quindi rischia di tradire gli ideali per cui si era
formato contro il potere assoluto di Cesare. Cassio ha compiuto azioni riprovevoli, che saranno
esplicitate tra poco, e Bruto, il rappresentante più puro della ideologia repubblicana, vorrebbe a
questo punto che non fosse stato fatto quello che è stato fatto, o che lo si potesse disfare. Tutta
la scena mostrerà come l’ideale non regga alla prova del reale. E lo stesso Bruto si rivelerà
contraddittorio, nel suo disperato tentativo di far tornare i conti tra ideologia e prassi.
136 IV, ii, 21 Ancora una volta, nella prospettiva repubblicana, la parola ceremony afferisce al campo
semantico dell’inganno, della facciata esteriore, della ritualità vuota.
137 IV, ii, 26 deceitful: il significato sembra essere doppio: ronzini che hanno ingannato presentandosi
come cavalli di razza (con solito gioco tra apparenza e realtà), ronzini che deludono in quanto tali
perché non reggono a nessuna prova importante. È singolare che Bruto usi per Cassio un’immagine