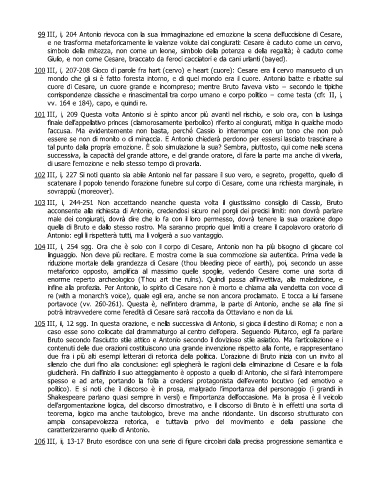Page 2284 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2284
99 III, i, 204 Antonio rievoca con la sua immaginazione ed emozione la scena dell’uccisione di Cesare,
e ne trasforma metaforicamente le valenze volute dai congiurati: Cesare è caduto come un cervo,
simbolo della mitezza, non come un leone, simbolo della potenza e della regalità; è caduto come
Giulio, e non come Cesare, braccato da feroci cacciatori e da cani urlanti (bayed).
100 III, i, 207-208 Gioco di parole fra hart (cervo) e heart (cuore): Cesare era il cervo mansueto di un
mondo che gli si è fatto foresta intorno, e di quel mondo era il cuore. Antonio batte e ribatte sul
cuore di Cesare, un cuore grande e incompreso; mentre Bruto l’aveva visto − secondo le tipiche
corrispondenze classiche e rinascimentali tra corpo umano e corpo politico − come testa (cfr. II, i,
vv. 164 e 184), capo, e quindi re.
101 III, i, 209 Questa volta Antonio si è spinto ancor più avanti nel rischio, e solo ora, con la lusinga
finale dell’appellativo princes (clamorosamente iperbolico) riferito ai congiurati, mitiga in qualche modo
l’accusa. Ma evidentemente non basta, perché Cassio lo interrompe con un tono che non può
essere se non di monito o di minaccia. E Antonio chiederà perdono per essersi lasciato trascinare a
tal punto dalla propria emozione. È solo simulazione la sua? Sembra, piuttosto, qui come nella scena
successiva, la capacità del grande attore, e del grande oratore, di fare la parte ma anche di viverla,
di usare l’emozione e nello stesso tempo di provarla.
102 III, i, 227 Si noti quanto sia abile Antonio nel far passare il suo vero, e segreto, progetto, quello di
scatenare il popolo tenendo l’orazione funebre sul corpo di Cesare, come una richiesta marginale, in
sovrappiù (moreover).
103 III, i, 244-251 Non accettando neanche questa volta il giustissimo consiglio di Cassio, Bruto
acconsente alla richiesta di Antonio, credendosi sicuro nel porgli dei precisi limiti: non dovrà parlare
male dei congiurati, dovrà dire che lo fa con il loro permesso, dovrà tenere la sua orazione dopo
quella di Bruto e dallo stesso rostro. Ma saranno proprio quei limiti a creare il capolavoro oratorio di
Antonio: egli li rispetterà tutti, ma li volgerà a suo vantaggio.
104 III, i, 254 sgg. Ora che è solo con il corpo di Cesare, Antonio non ha più bisogno di giocare col
linguaggio. Non deve più recitare. E mostra come la sua commozione sia autentica. Prima vede la
riduzione mortale della grandezza di Cesare (thou bleeding piece of earth), poi, secondo un asse
metaforico opposto, amplifica al massimo quelle spoglie, vedendo Cesare come una sorta di
enorme reperto archeologico (Thou art the ruins). Quindi passa all’invettiva, alla maledizione, e
infine alla profezia. Per Antonio, lo spirito di Cesare non è morto e chiama alla vendetta con voce di
re (with a monarch’s voice), quale egli era, anche se non ancora proclamato. E tocca a lui farsene
portavoce (vv. 260-261). Questa è, nell’intero dramma, la parte di Antonio, anche se alla fine si
potrà intravvedere come l’eredità di Cesare sarà raccolta da Ottaviano e non da lui.
105 III, ii, 12 sgg. In questa orazione, e nella successiva di Antonio, si gioca il destino di Roma; e non a
caso esse sono collocate dal drammaturgo al centro dell’opera. Seguendo Plutarco, egli fa parlare
Bruto secondo l’asciutto stile attico e Antonio secondo il dovizioso stile asiatico. Ma l’articolazione e i
contenuti delle due orazioni costituiscono una grande invenzione rispetto alla fonte, e rappresentano
due fra i più alti esempi letterari di retorica della politica. L’orazione di Bruto inizia con un invito al
silenzio che duri fino alla conclusione: egli spiegherà le ragioni della eliminazione di Cesare e la folla
giudicherà. Fin dall’inizio il suo atteggiamento è opposto a quello di Antonio, che si farà interrompere
spesso e ad arte, portando la folla a credersi protagonista dell’evento locutivo (ed emotivo e
politico). E si noti che il discorso è in prosa, malgrado l’importanza del personaggio (i grandi in
Shakespeare parlano quasi sempre in versi) e l’importanza dell’occasione. Ma la prosa è il veicolo
dell’argomentazione logica, del discorso dimostrativo, e il discorso di Bruto è in effetti una sorta di
teorema, logico ma anche tautologico, breve ma anche ridondante. Un discorso strutturato con
ampia consapevolezza retorica, e tuttavia privo del movimento e della passione che
caratterizzeranno quello di Antonio.
106 III, ii, 13-17 Bruto esordisce con una serie di figure circolari dalla precisa progressione semantica e