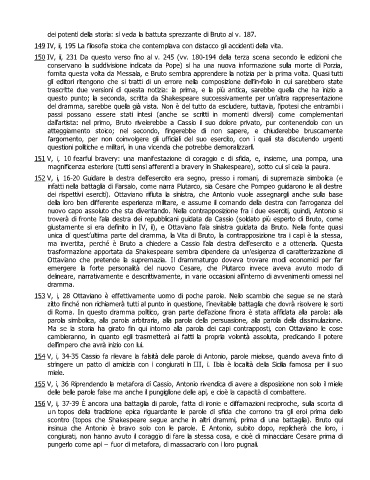Page 2290 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2290
dei potenti della storia: si veda la battuta sprezzante di Bruto al v. 187.
149 IV, ii, 195 La filosofia stoica che contemplava con distacco gli accidenti della vita.
150 IV, ii, 231 Da questo verso fino al v. 245 (vv. 180-194 della terza scena secondo le edizioni che
conservano la suddivisione indicata da Pope) si ha una nuova informazione sulla morte di Porzia,
fornita questa volta da Messala, e Bruto sembra apprendere la notizia per la prima volta. Quasi tutti
gli editori ritengono che si tratti di un errore nella composizione dell’in-folio in cui sarebbero state
trascritte due versioni di questa notizia: la prima, e la più antica, sarebbe quella che ha inizio a
questo punto; la seconda, scritta da Shakespeare successivamente per un’altra rappresentazione
del dramma, sarebbe quella già vista. Non è del tutto da escludere, tuttavia, l’ipotesi che entrambi i
passi possano essere stati intesi (anche se scritti in momenti diversi) come complementari
dall’artista: nel primo, Bruto rivelerebbe a Cassio il suo dolore privato, pur contenendolo con un
atteggiamento stoico; nel secondo, fingerebbe di non sapere, e chiuderebbe bruscamente
l’argomento, per non coinvolgere gli ufficiali del suo esercito, con i quali sta discutendo urgenti
questioni politiche e militari, in una vicenda che potrebbe demoralizzarli.
151 V, i, 10 fearful bravery: una manifestazione di coraggio e di sfida, e, insieme, una pompa, una
magnificenza esteriore (tutti sensi afferenti a bravery in Shakespeare), sotto cui si cela la paura.
152 V, i, 16-20 Guidare la destra dell’esercito era segno, presso i romani, di supremazia simbolica (e
infatti nella battaglia di Farsalo, come narra Plutarco, sia Cesare che Pompeo guidarono le ali destre
dei rispettivi eserciti). Ottaviano rifiuta la sinistra, che Antonio vuole assegnargli anche sulla base
della loro ben differente esperienza militare, e assume il comando della destra con l’arroganza del
nuovo capo assoluto che sta diventando. Nella contrapposizione fra i due eserciti, quindi, Antonio si
troverà di fronte l’ala destra dei repubblicani guidata da Cassio (soldato più esperto di Bruto, come
giustamente si era definito in IV, ii), e Ottaviano l’ala sinistra guidata da Bruto. Nella fonte quasi
unica di quest’ultima parte del dramma, la Vita di Bruto, la contrapposizione tra i capi è la stessa,
ma invertita, perché è Bruto a chiedere a Cassio l’ala destra dell’esercito e a ottenerla. Questa
trasformazione apportata da Shakespeare sembra dipendere da un’esigenza di caratterizzazione di
Ottaviano che pretende la supremazia. Il drammaturgo doveva trovare modi economici per far
emergere la forte personalità del nuovo Cesare, che Plutarco invece aveva avuto modo di
delineare, narrativamente e descrittivamente, in varie occasioni all’interno di avvenimenti omessi nel
dramma.
153 V, i, 28 Ottaviano è effettivamente uomo di poche parole. Nello scambio che segue se ne starà
zitto finché non richiamerà tutti al punto in questione, l’inevitabile battaglia che dovrà risolvere le sorti
di Roma. In questo dramma politico, gran parte dell’azione finora è stata affidata alla parola: alla
parola simbolica, alla parola arbitraria, alla parola della persuasione, alla parola della dissimulazione.
Ma se la storia ha girato fin qui intorno alla parola dei capi contrapposti, con Ottaviano le cose
cambieranno, in quanto egli trasmetterà ai fatti la propria volontà assoluta, predicando il potere
dell’impero che avrà inizio con lui.
154 V, i, 34-35 Cassio fa rilevare la falsità delle parole di Antonio, parole mielose, quando aveva finto di
stringere un patto di amicizia con i congiurati in III, i. Ibla è località della Sicilia famosa per il suo
miele.
155 V, i, 36 Riprendendo la metafora di Cassio, Antonio rivendica di avere a disposizione non solo il miele
delle belle parole false ma anche il pungiglione delle api, e cioè la capacità di combattere.
156 V, i, 37-39 È ancora una battaglia di parole, fatta di ironie e diffamazioni reciproche, sulla scorta di
un topos della tradizione epica riguardante le parole di sfida che corrono tra gli eroi prima dello
scontro (topos che Shakespeare segue anche in altri drammi, prima di una battaglia). Bruto qui
insinua che Antonio è bravo solo con le parole. E Antonio, subito dopo, replicherà che loro, i
congiurati, non hanno avuto il coraggio di fare la stessa cosa, e cioè di minacciare Cesare prima di
pungerlo come api − fuor di metafora, di massacrarlo con i loro pugnali.