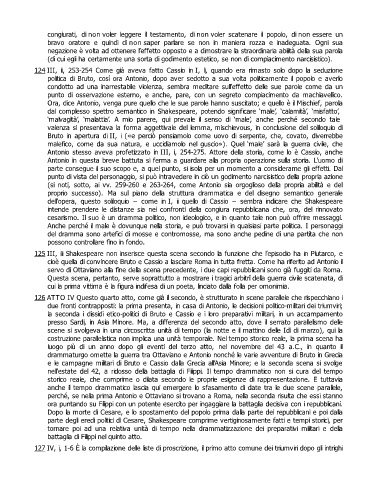Page 2287 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2287
congiurati, di non voler leggere il testamento, di non voler scatenare il popolo, di non essere un
bravo oratore e quindi di non saper parlare se non in maniera rozza e inadeguata. Ogni sua
negazione è volta ad ottenere l’effetto opposto e a dimostrare la straordinaria abilità della sua parola
(di cui egli ha certamente una sorta di godimento estetico, se non di compiacimento narcisistico).
124 III, ii, 253-254 Come già aveva fatto Cassio in I, ii, quando era rimasto solo dopo la seduzione
politica di Bruto, così ora Antonio, dopo aver sedotto a sua volta politicamente il popolo e averlo
condotto ad una inarrestabile violenza, sembra meditare sull’effetto delle sue parole come da un
punto di osservazione esterno, e anche, pare, con un segreto compiacimento da machiavellico.
Ora, dice Antonio, venga pure quello che le sue parole hanno suscitato; e quello è il Mischief, parola
dal complesso spettro semantico in Shakespeare, potendo significare ‘male’, ‘calamità’, ‘misfatto’,
‘malvagità’, ‘malattia’. A mio parere, qui prevale il senso di ‘male’, anche perché secondo tale
valenza si presentava la forma aggettivale del lemma, mischievous, in conclusione del soliloquio di
Bruto in apertura di II, i («e perciò pensiamolo come uovo di serpente, che, covato, diverrebbe
malefico, come da sua natura, e uccidiamolo nel guscio»). Quel ‘male’ sarà la guerra civile, che
Antonio stesso aveva profetizzato in III, i, 254-275. Attore della storia, come lo è Cassio, anche
Antonio in questa breve battuta si ferma a guardare alla propria operazione sulla storia. L’uomo di
parte consegue il suo scopo e, a quel punto, si isola per un momento a considerarne gli effetti. Dal
punto di vista del personaggio, si può intravedere in ciò un godimento narcisistico della propria azione
(si noti, sotto, ai vv. 259-260 e 263-264, come Antonio sia orgoglioso della propria abilità e del
proprio successo). Ma sul piano della struttura drammatica e del disegno semantico generale
dell’opera, questo soliloquio − come in I, ii quello di Cassio − sembra indicare che Shakespeare
intende prendere le distanze sia nei confronti della congiura repubblicana che, ora, del rinnovato
cesarismo. Il suo è un dramma politico, non ideologico, e in quanto tale non può offrire messaggi.
Anche perché il male è dovunque nella storia, e può trovarsi in qualsiasi parte politica. I personaggi
del dramma sono artefici di mosse e contromosse, ma sono anche pedine di una partita che non
possono controllare fino in fondo.
125 III, iii Shakespeare non inserisce questa scena secondo la funzione che l’episodio ha in Plutarco, e
cioè quella di convincere Bruto e Cassio a lasciare Roma in tutta fretta. Come ha riferito ad Antonio il
servo di Ottaviano alla fine della scena precedente, i due capi repubblicani sono già fuggiti da Roma.
Questa scena, pertanto, serve soprattutto a mostrare i tragici arbitrî della guerra civile scatenata, di
cui la prima vittima è la figura indifesa di un poeta, linciato dalla folla per omonimia.
126 ATTO IV Questo quarto atto, come già il secondo, è strutturato in scene parallele che rispecchiano i
due fronti contrapposti: la prima presenta, in casa di Antonio, le decisioni politico-militari dei triumviri;
la seconda i dissidi etico-politici di Bruto e Cassio e i loro preparativi militari, in un accampamento
presso Sardi, in Asia Minore. Ma, a differenza del secondo atto, dove il serrato parallelismo delle
scene si svolgeva in una circoscritta unità di tempo (la notte e il mattino delle Idi di marzo), qui la
costruzione parallelistica non implica una unità temporale. Nel tempo storico reale, la prima scena ha
luogo più di un anno dopo gli eventi del terzo atto, nel novembre del 43 a.C., in quanto il
drammaturgo omette la guerra tra Ottaviano e Antonio nonché le varie avventure di Bruto in Grecia
e le campagne militari di Bruto e Cassio dalla Grecia all’Asia Minore; e la seconda scena si svolge
nell’estate del 42, a ridosso della battaglia di Filippi. Il tempo drammatico non si cura del tempo
storico reale, che comprime o dilata secondo le proprie esigenze di rappresentazione. E tuttavia
anche il tempo drammatico lascia qui emergere lo sfasamento di date tra le due scene parallele,
perché, se nella prima Antonio e Ottaviano si trovano a Roma, nella seconda risulta che essi stanno
ora puntando su Filippi con un potente esercito per ingaggiare la battaglia decisiva con i repubblicani.
Dopo la morte di Cesare, e lo spostamento del popolo prima dalla parte dei repubblicani e poi dalla
parte degli eredi politici di Cesare, Shakespeare comprime vertiginosamente fatti e tempi storici, per
tornare poi ad una relativa unità di tempo nella drammatizzazione dei preparativi militari e della
battaglia di Filippi nel quinto atto.
127 IV, i, 1-6 È la compilazione delle liste di proscrizione, il primo atto comune dei triumviri dopo gli intrighi