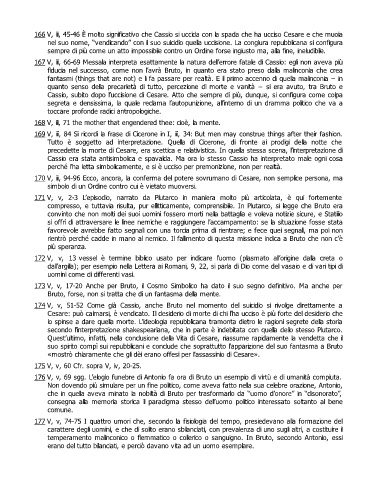Page 2292 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2292
166 V, iii, 45-46 È molto significativo che Cassio si uccida con la spada che ha ucciso Cesare e che muoia
nel suo nome, “vendicando” con il suo suicidio quella uccisione. La congiura repubblicana si configura
sempre di più come un atto impossibile contro un Ordine forse ingiusto ma, alla fine, ineludibile.
167 V, iii, 66-69 Messala interpreta esattamente la natura dell’errore fatale di Cassio: egli non aveva più
fiducia nel successo, come non l’avrà Bruto, in quanto era stato preso dalla malinconia che crea
fantasmi (things that are not) e li fa passare per realtà. E il primo accenno di quella malinconia − in
quanto senso della precarietà di tutto, percezione di morte e vanità − si era avuto, tra Bruto e
Cassio, subito dopo l’uccisione di Cesare. Atto che sempre di più, dunque, si configura come colpa
segreta e densissima, la quale reclama l’autopunizione, all’interno di un dramma politico che va a
toccare profonde radici antropologiche.
168 V, iii, 71 the mother that engendered thee: cioè, la mente.
169 V, iii, 84 Si ricordi la frase di Cicerone in I, iii, 34: But men may construe things after their fashion.
Tutto è soggetto ad interpretazione. Quella di Cicerone, di fronte ai prodigi della notte che
precedette la morte di Cesare, era scettica e relativistica. In quella stessa scena, l’interpretazione di
Cassio era stata antisimbolica e spavalda. Ma ora lo stesso Cassio ha interpretato male ogni cosa
perché l’ha letta simbolicamente, e si è ucciso per premonizione, non per realtà.
170 V, iii, 94-96 Ecco, ancora, la conferma del potere sovrumano di Cesare, non semplice persona, ma
simbolo di un Ordine contro cui è vietato muoversi.
171 V, v, 2-3 L’episodio, narrato da Plutarco in maniera molto più articolata, è qui fortemente
compresso, e tuttavia risulta, pur ellitticamente, comprensibile. In Plutarco, si legge che Bruto era
convinto che non molti dei suoi uomini fossero morti nella battaglia e voleva notizie sicure, e Statilio
si offrì di attraversare le linee nemiche e raggiungere l’accampamento: se la situazione fosse stata
favorevole avrebbe fatto segnali con una torcia prima di rientrare; e fece quei segnali, ma poi non
rientrò perché cadde in mano al nemico. Il fallimento di questa missione indica a Bruto che non c’è
più speranza.
172 V, v, 13 vessel è termine biblico usato per indicare l’uomo (plasmato all’origine dalla creta o
dall’argilla); per esempio nella Lettera ai Romani, 9, 22, si parla di Dio come del vasaio e di vari tipi di
uomini come di differenti vasi.
173 V, v, 17-20 Anche per Bruto, il Cosmo Simbolico ha dato il suo segno definitivo. Ma anche per
Bruto, forse, non si tratta che di un fantasma della mente.
174 V, v, 51-52 Come già Cassio, anche Bruto nel momento del suicidio si rivolge direttamente a
Cesare: può calmarsi, è vendicato. Il desiderio di morte di chi l’ha ucciso è più forte del desiderio che
lo spinse a dare quella morte. L’ideologia repubblicana tramonta dietro le ragioni segrete della storia
secondo l’interpretazione shakespeariana, che in parte è indebitata con quella dello stesso Plutarco.
Quest’ultimo, infatti, nella conclusione della Vita di Cesare, riassume rapidamente la vendetta che il
suo spirito compì sui repubblicani e conclude che soprattutto l’apparizione del suo fantasma a Bruto
«mostrò chiaramente che gli dèi erano offesi per l’assassinio di Cesare».
175 V, v, 60 Cfr. sopra V, iv, 20-25.
176 V, v, 69 sgg. L’elogio funebre di Antonio fa ora di Bruto un esempio di virtù e di umanità compiuta.
Non dovendo più simulare per un fine politico, come aveva fatto nella sua celebre orazione, Antonio,
che in quella aveva minato la nobiltà di Bruto per trasformarlo da “uomo d’onore” in “disonorato”,
consegna alla memoria storica il paradigma stesso dell’uomo politico interessato soltanto al bene
comune.
177 V, v, 74-75 I quattro umori che, secondo la fisiologia del tempo, presiedevano alla formazione del
carattere degli uomini, e che di solito erano sbilanciati, con prevalenza di uno sugli altri, a costituire il
temperamento malinconico o flemmatico o collerico o sanguigno. In Bruto, secondo Antonio, essi
erano del tutto bilanciati, e perciò davano vita ad un uomo esemplare.