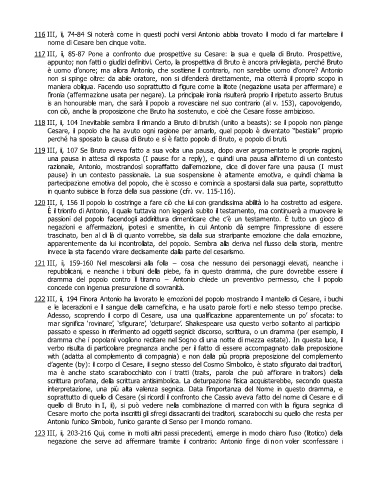Page 2286 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2286
116 III, ii, 74-84 Si noterà come in questi pochi versi Antonio abbia trovato il modo di far martellare il
nome di Cesare ben cinque volte.
117 III, ii, 85-87 Pone a confronto due prospettive su Cesare: la sua e quella di Bruto. Prospettive,
appunto; non fatti o giudizi definitivi. Certo, la prospettiva di Bruto è ancora privilegiata, perché Bruto
è uomo d’onore; ma allora Antonio, che sostiene il contrario, non sarebbe uomo d’onore? Antonio
non si spinge oltre: da abile oratore, non si difenderà direttamente, ma otterrà il proprio scopo in
maniera obliqua. Facendo uso soprattutto di figure come la litote (negazione usata per affermare) e
l’ironia (affermazione usata per negare). La principale ironia risulterà proprio il ripetuto asserto Brutus
is an honourable man, che sarà il popolo a rovesciare nel suo contrario (al v. 153), capovolgendo,
con ciò, anche la proposizione che Bruto ha sostenuto, e cioè che Cesare fosse ambizioso.
118 III, ii, 104 Inevitabile sembra il rimando a Bruto di brutish (unito a beasts): se il popolo non piange
Cesare, il popolo che ha avuto ogni ragione per amarlo, quel popolo è diventato “bestiale” proprio
perché ha sposato la causa di Bruto e si è fatto popolo di Bruto, e popolo di bruti.
119 III, ii, 107 Se Bruto aveva fatto a sua volta una pausa, dopo aver argomentato le proprie ragioni,
una pausa in attesa di risposta (I pause for a reply), e quindi una pausa all’interno di un contesto
razionale, Antonio, mostrandosi sopraffatto dall’emozione, dice di dover fare una pausa (I must
pause) in un contesto passionale. La sua sospensione è altamente emotiva, e quindi chiama la
partecipazione emotiva del popolo, che è scosso e comincia a spostarsi dalla sua parte, soprattutto
in quanto subisce la forza della sua passione (cfr. vv. 115-116).
120 III, ii, 156 Il popolo lo costringe a fare ciò che lui con grandissima abilità lo ha costretto ad esigere.
È il trionfo di Antonio, il quale tuttavia non leggerà subito il testamento, ma continuerà a muovere le
passioni del popolo facendogli addirittura dimenticare che c’è un testamento. È tutto un gioco di
negazioni e affermazioni, ipotesi e smentite, in cui Antonio dà sempre l’impressione di essere
trascinato, ben al di là di quanto vorrebbe, sia dalla sua straripante emozione che dalla emozione,
apparentemente da lui incontrollata, del popolo. Sembra alla deriva nel flusso della storia, mentre
invece la sta facendo virare decisamente dalla parte del cesarismo.
121 III, ii, 159-160 Nel mescolarsi alla folla − cosa che nessuno dei personaggi elevati, neanche i
repubblicani, e neanche i tribuni della plebe, fa in questo dramma, che pure dovrebbe essere il
dramma del popolo contro il tiranno − Antonio chiede un preventivo permesso, che il popolo
concede con ingenua presunzione di sovranità.
122 III, ii, 194 Finora Antonio ha lavorato le emozioni del popolo mostrando il mantello di Cesare, i buchi
e le lacerazioni e il sangue della carneficina, e ha usato parole forti e nello stesso tempo precise.
Adesso, scoprendo il corpo di Cesare, usa una qualificazione apparentemente un po’ sfocata: to
mar significa ‘rovinare’, ‘sfigurare’, ‘deturpare’. Shakespeare usa questo verbo soltanto al participio
passato e spesso in riferimento ad oggetti segnici: discorso, scrittura, o un dramma (per esempio, il
dramma che i popolani vogliono recitare nel Sogno di una notte di mezza estate). In questa luce, il
verbo risulta di particolare pregnanza anche per il fatto di essere accompagnato dalla preposizione
with (adatta al complemento di compagnia) e non dalla più propria preposizione del complemento
d’agente (by): il corpo di Cesare, il segno stesso del Cosmo Simbolico, è stato sfigurato dai traditori,
ma è anche stato scarabocchiato con i tratti (traits, parola che può affiorare in traitors) della
scrittura profana, della scrittura antisimbolica. La deturpazione fisica acquisterebbe, secondo questa
interpretazione, una più alta valenza segnica. Data l’importanza del Nome in questo dramma, e
soprattutto di quello di Cesare (si ricordi il confronto che Cassio aveva fatto del nome di Cesare e di
quello di Bruto in I, ii), si può vedere nella combinazione di marred con with la figura segnica di
Cesare morto che porta inscritti gli sfregi dissacranti dei traditori, scarabocchi su quello che resta per
Antonio l’unico Simbolo, l’unico garante di Senso per il mondo romano.
123 III, ii, 203-216 Qui, come in molti altri passi precedenti, emerge in modo chiaro l’uso (litotico) della
negazione che serve ad affermare tramite il contrario: Antonio finge di non voler sconfessare i