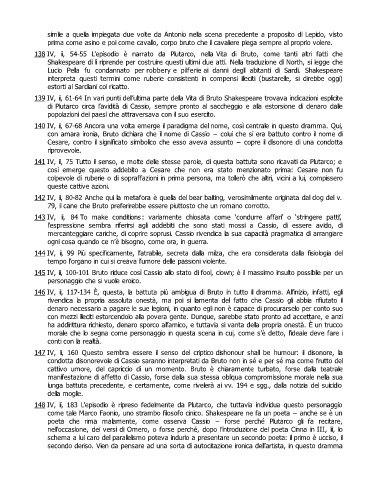Page 2289 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2289
simile a quella impiegata due volte da Antonio nella scena precedente a proposito di Lepido, visto
prima come asino e poi come cavallo, corpo bruto che il cavaliere piega sempre al proprio volere.
138 IV, ii, 54-55 L’episodio è narrato da Plutarco, nella Vita di Bruto, come tanti altri fatti che
Shakespeare di lì riprende per costruire questi ultimi due atti. Nella traduzione di North, si legge che
Lucio Pella fu condannato per robbery e pilferie ai danni degli abitanti di Sardi. Shakespeare
interpreta questi termini come ruberie consistenti in compensi illeciti (bustarelle, si direbbe oggi)
estorti ai Sardiani col ricatto.
139 IV, ii, 61-64 In vari punti dell’ultima parte della Vita di Bruto Shakespeare trovava indicazioni esplicite
di Plutarco circa l’avidità di Cassio, sempre pronto al saccheggio e alla estorsione di denaro dalle
popolazioni dei paesi che attraversava con il suo esercito.
140 IV, ii, 67-68 Ancora una volta emerge il paradigma del nome, così centrale in questo dramma. Qui,
con amara ironia, Bruto dichiara che il nome di Cassio − colui che si era battuto contro il nome di
Cesare, contro il significato simbolico che esso aveva assunto − copre il disonore di una condotta
riprovevole.
141 IV, ii, 75 Tutto il senso, e molte delle stesse parole, di questa battuta sono ricavati da Plutarco; e
così emerge questo addebito a Cesare che non era stato menzionato prima: Cesare non fu
colpevole di ruberie o di sopraffazioni in prima persona, ma tollerò che altri, vicini a lui, compissero
queste cattive azioni.
142 IV, ii, 80-82 Anche qui la metafora è quella del bear baiting, verosimilmente originata dal dog del v.
79, il cane che Bruto preferirebbe essere piuttosto che un romano corrotto.
143 IV, ii, 84 To make conditions : variamente chiosata come ‘condurre affari’ o ‘stringere patti’,
l’espressione sembra riferirsi agli addebiti che sono stati mossi a Cassio, di essere avido, di
mercanteggiare cariche, di coprire soprusi. Cassio rivendica la sua capacità pragmatica di arrangiare
ogni cosa quando ce n’è bisogno, come ora, in guerra.
144 IV, ii, 99 Più specificamente, l’atrabile, secreta dalla milza, che era considerata dalla fisiologia del
tempo l’organo in cui si creava l’umore delle passioni violente.
145 IV, ii, 100-101 Bruto riduce così Cassio allo stato di fool, clown; è il massimo insulto possibile per un
personaggio che si vuole eroico.
146 IV, ii, 117-134 È, questa, la battuta più ambigua di Bruto in tutto il dramma. All’inizio, infatti, egli
rivendica la propria assoluta onestà, ma poi si lamenta del fatto che Cassio gli abbia rifiutato il
denaro necessario a pagare le sue legioni, in quanto egli non è capace di procurarselo per conto suo
con mezzi illeciti estorcendolo alla povera gente. Dunque, sarebbe stato pronto ad accettare, e anzi
ha addirittura richiesto, denaro sporco all’amico, e tuttavia si vanta della propria onestà. È un trucco
morale che lo segna come personaggio in questa scena in cui, come s’è detto, l’ideale deve fare i
conti con la realtà.
147 IV, ii, 160 Questo sembra essere il senso del criptico dishonour shall be humour: il disonore, la
condotta disonorevole di Cassio saranno interpretati da Bruto non in sé e per sé ma come frutto del
cattivo umore, del capriccio di un momento. Bruto è chiaramente turbato, forse dalla teatrale
manifestazione di affetto di Cassio, forse dalla sua stessa obliqua compromissione morale nella sua
lunga battuta precedente, e certamente, come rivelerà ai vv. 194 e sgg., dalla notizia del suicidio
della moglie.
148 IV, ii, 183 L’episodio è ripreso fedelmente da Plutarco, che tuttavia individua questo personaggio
come tale Marco Faonio, uno strambo filosofo cinico. Shakespeare ne fa un poeta − anche se è un
poeta che rima malamente, come osserva Cassio − forse perché Plutarco gli fa recitare,
nell’occasione, dei versi di Omero, o forse perché, dopo l’introduzione del poeta Cinna in III, iii, lo
schema a lui caro del parallelismo poteva indurlo a presentare un secondo poeta: il primo è ucciso, il
secondo deriso. Vien da pensare ad una sorta di autocitazione ironica dell’artista, in questo dramma