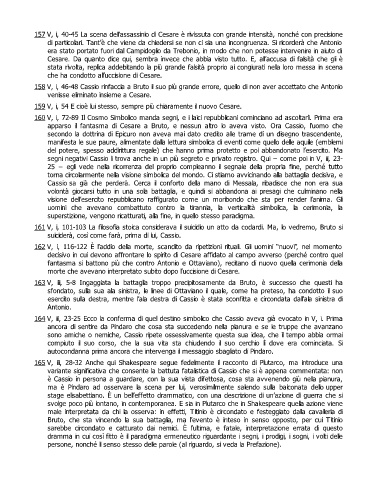Page 2291 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2291
157 V, i, 40-45 La scena dell’assassinio di Cesare è rivissuta con grande intensità, nonché con precisione
di particolari. Tant’è che viene da chiedersi se non ci sia una incongruenza. Si ricorderà che Antonio
era stato portato fuori dal Campidoglio da Trebonio, in modo che non potesse intervenire in aiuto di
Cesare. Da quanto dice qui, sembra invece che abbia visto tutto. E, all’accusa di falsità che gli è
stata rivolta, replica addebitando la più grande falsità proprio ai congiurati nella loro messa in scena
che ha condotto all’uccisione di Cesare.
158 V, i, 46-48 Cassio rinfaccia a Bruto il suo più grande errore, quello di non aver accettato che Antonio
venisse eliminato insieme a Cesare.
159 V, i, 54 E cioè lui stesso, sempre più chiaramente il nuovo Cesare.
160 V, i, 72-89 Il Cosmo Simbolico manda segni, e i laici repubblicani cominciano ad ascoltarli. Prima era
apparso il fantasma di Cesare a Bruto, e nessun altro lo aveva visto. Ora Cassio, l’uomo che
secondo la dottrina di Epicuro non aveva mai dato credito alle trame di un disegno trascendente,
manifesta le sue paure, alimentate dalla lettura simbolica di eventi come quello delle aquile (emblemi
del potere, spesso addirittura regale) che hanno prima protetto e poi abbandonato l’esercito. Ma
segni negativi Cassio li trova anche in un più segreto e privato registro. Qui − come poi in V, iii, 23-
25 − egli vede nella ricorrenza del proprio compleanno il segnale della propria fine, perché tutto
torna circolarmente nella visione simbolica del mondo. Ci stiamo avvicinando alla battaglia decisiva, e
Cassio sa già che perderà. Cerca il conforto della mano di Messala, ribadisce che non era sua
volontà giocarsi tutto in una sola battaglia, e quindi si abbandona ai presagi che culminano nella
visione dell’esercito repubblicano raffigurato come un moribondo che sta per render l’anima. Gli
uomini che avevano combattuto contro la tirannia, la verticalità simbolica, la cerimonia, la
superstizione, vengono ricatturati, alla fine, in quello stesso paradigma.
161 V, i, 101-103 La filosofia stoica considerava il suicidio un atto da codardi. Ma, lo vedremo, Bruto si
suiciderà, così come farà, prima di lui, Cassio.
162 V, i, 116-122 È l’addio della morte, scandito da ripetizioni rituali. Gli uomini “nuovi”, nel momento
decisivo in cui devono affrontare lo spirito di Cesare affidato al campo avverso (perché contro quel
fantasma si battono più che contro Antonio e Ottaviano), recitano di nuovo quella cerimonia della
morte che avevano interpretato subito dopo l’uccisione di Cesare.
163 V, iii, 5-8 Ingaggiata la battaglia troppo precipitosamente da Bruto, è successo che questi ha
sfondato, sulla sua ala sinistra, le linee di Ottaviano il quale, come ha preteso, ha condotto il suo
esercito sulla destra, mentre l’ala destra di Cassio è stata sconfitta e circondata dall’ala sinistra di
Antonio.
164 V, iii, 23-25 Ecco la conferma di quel destino simbolico che Cassio aveva già evocato in V, i. Prima
ancora di sentire da Pindaro che cosa sta succedendo nella pianura e se le truppe che avanzano
sono amiche o nemiche, Cassio ripete ossessivamente questa sua idea, che il tempo abbia ormai
compiuto il suo corso, che la sua vita sta chiudendo il suo cerchio lì dove era cominciata. Si
autocondanna prima ancora che intervenga il messaggio sbagliato di Pindaro.
165 V, iii, 28-32 Anche qui Shakespeare segue fedelmente il racconto di Plutarco, ma introduce una
variante significativa che consente la battuta fatalistica di Cassio che si è appena commentata: non
è Cassio in persona a guardare, con la sua vista difettosa, cosa sta avvenendo giù nella pianura,
ma è Pindaro ad osservare la scena per lui, verosimilmente salendo sulla balconata dello upper
stage elisabettiano. È un bell’effetto drammatico, con una descrizione di un’azione di guerra che si
svolge poco più lontano, in contemporanea. E sia in Plutarco che in Shakespeare quella azione viene
male interpretata da chi la osserva: in effetti, Titinio è circondato e festeggiato dalla cavalleria di
Bruto, che sta vincendo la sua battaglia, ma l’evento è inteso in senso opposto, per cui Titinio
sarebbe circondato e catturato dai nemici. È l’ultima, e fatale, interpretazione errata di questo
dramma in cui così fitto è il paradigma ermeneutico riguardante i segni, i prodigi, i sogni, i volti delle
persone, nonché il senso stesso delle parole (al riguardo, si veda la Prefazione).