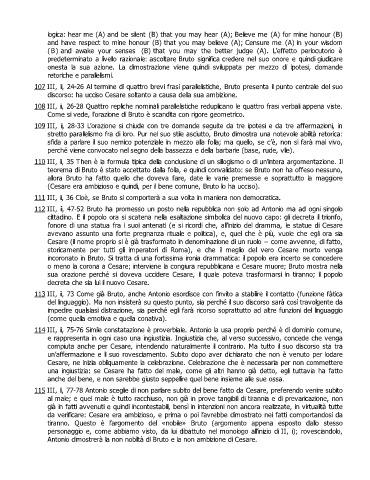Page 2285 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2285
logica: hear me (A) and be silent (B) that you may hear (A); Believe me (A) for mine honour (B)
and have respect to mine honour (B) that you may believe (A); Censure me (A) in your wisdom
(B) and awake your senses (B) that you may the better judge (A). L’effetto perlocutorio è
predeterminato a livello razionale: ascoltare Bruto significa credere nel suo onore e quindi giudicare
onesta la sua azione. La dimostrazione viene quindi sviluppata per mezzo di ipotesi, domande
retoriche e parallelismi.
107 III, ii, 24-26 Al termine di quattro brevi frasi parallelistiche, Bruto presenta il punto centrale del suo
discorso: ha ucciso Cesare soltanto a causa della sua ambizione.
108 III, ii, 26-28 Quattro repliche nominali parallelistiche reduplicano le quattro frasi verbali appena viste.
Come si vede, l’orazione di Bruto è scandita con rigore geometrico.
109 III, ii, 28-33 L’orazione si chiude con tre domande seguite da tre ipotesi e da tre affermazioni, in
stretto parallelismo fra di loro. Pur nel suo stile asciutto, Bruto dimostra una notevole abilità retorica:
sfida a parlare il suo nemico potenziale in mezzo alla folla; ma quello, se c’è, non si farà mai vivo,
perché viene convocato nel segno della bassezza e della barbarie (base, rude, vile).
110 III, ii, 35 Then è la formula tipica della conclusione di un sillogismo o di un’intera argomentazione. Il
teorema di Bruto è stato accettato dalla folla, e quindi convalidato: se Bruto non ha offeso nessuno,
allora Bruto ha fatto quello che doveva fare, date le varie premesse e soprattutto la maggiore
(Cesare era ambizioso e quindi, per il bene comune, Bruto lo ha ucciso).
111 III, ii, 36 Cioè, se Bruto si comporterà a sua volta in maniera non democratica.
112 III, ii, 47-52 Bruto ha promesso un posto nella repubblica non solo ad Antonio ma ad ogni singolo
cittadino. E il popolo ora si scatena nella esaltazione simbolica del nuovo capo: gli decreta il trionfo,
l’onore di una statua fra i suoi antenati (e si ricordi che, all’inizio del dramma, le statue di Cesare
avevano assunto una forte pregnanza rituale e politica), e, quel che è più, vuole che egli ora sia
Cesare (il nome proprio si è già trasformato in denominazione di un ruolo − come avvenne, di fatto,
storicamente per tutti gli imperatori di Roma), e che il meglio del vero Cesare morto venga
incoronato in Bruto. Si tratta di una fortissima ironia drammatica: il popolo era incerto se concedere
o meno la corona a Cesare; interviene la congiura repubblicana e Cesare muore; Bruto mostra nella
sua orazione perché si doveva uccidere Cesare, il quale poteva trasformarsi in tiranno; il popolo
decreta che sia lui il nuovo Cesare.
113 III, ii, 73 Come già Bruto, anche Antonio esordisce con l’invito a stabilire il contatto (funzione fàtica
del linguaggio). Ma non insisterà su questo punto, sia perché il suo discorso sarà così travolgente da
impedire qualsiasi distrazione, sia perché egli farà ricorso soprattutto ad altre funzioni del linguaggio
(come quella emotiva e quella conativa).
114 III, ii, 75-76 Simile constatazione è proverbiale. Antonio la usa proprio perché è di dominio comune,
e rappresenta in ogni caso una ingiustizia. Ingiustizia che, al verso successivo, concede che venga
compiuta anche per Cesare, intendendo naturalmente il contrario. Ma tutto il suo discorso sta tra
un’affermazione e il suo rovesciamento. Subito dopo aver dichiarato che non è venuto per lodare
Cesare, ne inizia obliquamente la celebrazione. Celebrazione che è necessaria per non commettere
una ingiustizia: se Cesare ha fatto del male, come gli altri hanno già detto, egli tuttavia ha fatto
anche del bene, e non sarebbe giusto seppellire quel bene insieme alle sue ossa.
115 III, ii, 77-78 Antonio sceglie di non parlare subito del bene fatto da Cesare, preferendo venire subito
al male; e quel male è tutto racchiuso, non già in prove tangibili di tirannia e di prevaricazione, non
già in fatti avvenuti e quindi incontestabili, bensì in intenzioni non ancora realizzate, in virtualità tutte
da verificare: Cesare era ambizioso, e prima o poi l’avrebbe dimostrato nei fatti comportandosi da
tiranno. Questo è l’argomento del «nobile» Bruto (argomento appena esposto dallo stesso
personaggio e, come abbiamo visto, da lui dibattuto nel monologo all’inizio di II, i); rovesciandolo,
Antonio dimostrerà la non nobiltà di Bruto e la non ambizione di Cesare.