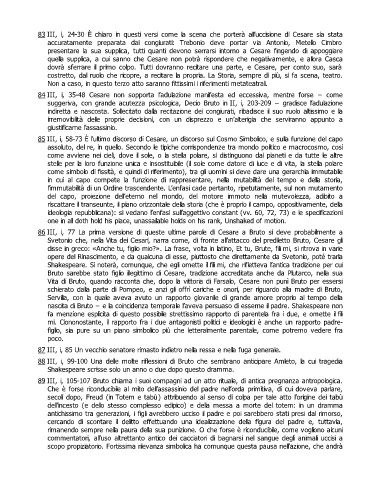Page 2282 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2282
83 III, i, 24-30 È chiaro in questi versi come la scena che porterà all’uccisione di Cesare sia stata
accuratamente preparata dai congiurati: Trebonio deve portar via Antonio, Metello Cimbro
presentare la sua supplica, tutti quanti devono serrarsi intorno a Cesare fingendo di appoggiare
quella supplica, a cui sanno che Cesare non potrà rispondere che negativamente, e allora Casca
dovrà sferrare il primo colpo. Tutti dovranno recitare una parte, e Cesare, per conto suo, sarà
costretto, dal ruolo che ricopre, a recitare la propria. La Storia, sempre di più, si fa scena, teatro.
Non a caso, in questo terzo atto saranno fittissimi i riferimenti metateatrali.
84 III, i, 35-48 Cesare non sopporta l’adulazione manifesta ed eccessiva, mentre forse − come
suggeriva, con grande acutezza psicologica, Decio Bruto in II, i, 203-209 − gradisce l’adulazione
indiretta e nascosta. Sollecitato dalla recitazione dei congiurati, ribadisce il suo ruolo altissimo e la
irremovibilità delle proprie decisioni, con un disprezzo e un’alterigia che serviranno appunto a
giustificarne l’assassinio.
85 III, i, 58-73 È l’ultimo discorso di Cesare, un discorso sul Cosmo Simbolico, e sulla funzione del capo
assoluto, del re, in quello. Secondo le tipiche corrispondenze tra mondo politico e macrocosmo, così
come avviene nei cieli, dove il sole, o la stella polare, si distinguono dai pianeti e da tutte le altre
stelle per la loro funzione unica e insostituibile (il sole come datore di luce e di vita, la stella polare
come simbolo di fissità, e quindi di riferimento), tra gli uomini si deve dare una gerarchia immutabile
in cui al capo compete la funzione di rappresentare, nella mutabilità del tempo e della storia,
l’immutabilità di un Ordine trascendente. L’enfasi cade pertanto, ripetutamente, sul non mutamento
del capo, proiezione dell’eterno nel mondo, del motore immoto nella mutevolezza, adibito a
riscattare il transeunte, il piano orizzontale della storia (che è proprio il campo, oppositivamente, della
ideologia repubblicana): si vedano l’enfasi sull’aggettivo constant (vv. 60, 72, 73) e le specificazioni
one in all doth hold his place, unassailable holds on his rank, Unshaked of motion.
86 III, i, 77 La prima versione di queste ultime parole di Cesare a Bruto si deve probabilmente a
Svetonio che, nella Vita dei Cesari, narra come, di fronte all’attacco del prediletto Bruto, Cesare gli
disse in greco: «Anche tu, figlio mio?». La frase, volta in latino, Et tu, Brute, fili mi, si ritrova in varie
opere del Rinascimento, e da qualcuna di esse, piuttosto che direttamente da Svetonio, poté trarla
Shakespeare. Si noterà, comunque, che egli omette il fili mi, che rifletteva l’antica tradizione per cui
Bruto sarebbe stato figlio illegittimo di Cesare, tradizione accreditata anche da Plutarco, nella sua
Vita di Bruto, quando racconta che, dopo la vittoria di Farsalo, Cesare non punì Bruto per essersi
schierato dalla parte di Pompeo, e anzi gli offrì cariche e onori, per riguardo alla madre di Bruto,
Servilia, con la quale aveva avuto un rapporto giovanile di grande amore proprio al tempo della
nascita di Bruto − e la coincidenza temporale l’aveva persuaso di esserne il padre. Shakespeare non
fa menzione esplicita di questo possibile strettissimo rapporto di parentela fra i due, e omette il fili
mi. Ciononostante, il rapporto fra i due antagonisti politici e ideologici è anche un rapporto padre-
figlio, sia pure su un piano simbolico più che letteralmente parentale, come potremo vedere fra
poco.
87 III, i, 85 Un vecchio senatore rimasto indietro nella ressa e nella fuga generale.
88 III, i, 99-100 Una delle molte riflessioni di Bruto che sembrano anticipare Amleto, la cui tragedia
Shakespeare scrisse solo un anno o due dopo questo dramma.
89 III, i, 105-107 Bruto chiama i suoi compagni ad un atto rituale, di antica pregnanza antropologica.
Che è forse riconducibile al mito dell’assassinio del padre nell’orda primitiva, di cui doveva parlare,
secoli dopo, Freud (in Totem e tabù) attribuendo al senso di colpa per tale atto l’origine dei tabù
dell’incesto (e dello stesso complesso edipico) e della messa a morte del totem: in un dramma
antichissimo tra generazioni, i figli avrebbero ucciso il padre e poi sarebbero stati presi dal rimorso,
cercando di scontare il delitto effettuando una idealizzazione della figura del padre e, tuttavia,
rimanendo sempre nella paura della sua punizione. O che forse è riconducibile, come vogliono alcuni
commentatori, all’uso altrettanto antico dei cacciatori di bagnarsi nel sangue degli animali uccisi a
scopo propiziatorio. Fortissima rilevanza simbolica ha comunque questa pausa nell’azione, che andrà