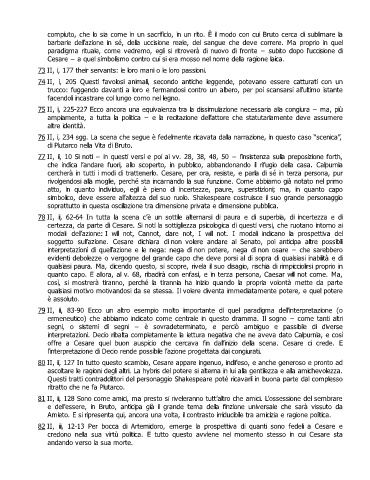Page 2281 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2281
compiuto, che lo sia come in un sacrificio, in un rito. È il modo con cui Bruto cerca di sublimare la
barbarie dell’azione in sé, della uccisione reale, del sangue che deve correre. Ma proprio in quel
paradigma rituale, come vedremo, egli si ritroverà di nuovo di fronte − subito dopo l’uccisione di
Cesare − a quel simbolismo contro cui si era mosso nel nome della ragione laica.
73 II, i, 177 their servants: le loro mani o le loro passioni.
74 II, i, 205 Questi favolosi animali, secondo antiche leggende, potevano essere catturati con un
trucco: fuggendo davanti a loro e fermandosi contro un albero, per poi scansarsi all’ultimo istante
facendoli incastrare col lungo corno nel legno.
75 II, i, 225-227 Ecco ancora una equivalenza tra la dissimulazione necessaria alla congiura − ma, più
ampiamente, a tutta la politica − e la recitazione dell’attore che statutariamente deve assumere
altre identità.
76 II, i, 234 sgg. La scena che segue è fedelmente ricavata dalla narrazione, in questo caso “scenica”,
di Plutarco nella Vita di Bruto.
77 II, ii, 10 Si noti − in questi versi e poi ai vv. 28, 38, 48, 50 − l’insistenza sulla preposizione forth,
che indica l’andare fuori, allo scoperto, in pubblico, abbandonando il rifugio della casa. Calpurnia
cercherà in tutti i modi di trattenerlo. Cesare, per ora, resiste, e parla di sé in terza persona, pur
rivolgendosi alla moglie, perché sta incarnando la sua funzione. Come abbiamo già notato nel primo
atto, in quanto individuo, egli è pieno di incertezze, paure, superstizioni; ma, in quanto capo
simbolico, deve essere all’altezza del suo ruolo. Shakespeare costruisce il suo grande personaggio
soprattutto in questa oscillazione tra dimensione privata e dimensione pubblica.
78 II, ii, 62-64 In tutta la scena c’è un sottile alternarsi di paura e di superbia, di incertezza e di
certezza, da parte di Cesare. Si noti la sottigliezza psicologica di questi versi, che ruotano intorno ai
modali dell’azione: I will not, Cannot, dare not, I will not. I modali indicano la prospettiva del
soggetto sull’azione. Cesare dichiara di non volere andare al Senato, poi anticipa altre possibili
interpretazioni di quell’azione e le nega: nega di non potere, nega di non osare − che sarebbero
evidenti debolezze o vergogne del grande capo che deve porsi al di sopra di qualsiasi inabilità e di
qualsiasi paura. Ma, dicendo questo, si scopre, rivela il suo disagio, rischia di rimpicciolirsi proprio in
quanto capo. E allora, al v. 68, ribadirà con enfasi, e in terza persona, Caesar will not come. Ma,
così, si mostrerà tiranno, perché la tirannia ha inizio quando la propria volontà mette da parte
qualsiasi motivo motivandosi da se stessa. Il volere diventa immediatamente potere, e quel potere
è assoluto.
79 II, ii, 83-90 Ecco un altro esempio molto importante di quel paradigma dell’interpretazione (o
ermeneutico) che abbiamo indicato come centrale in questo dramma. Il sogno − come tanti altri
segni, o sistemi di segni − è sovradeterminato, e perciò ambiguo e passibile di diverse
interpretazioni. Decio ribalta completamente la lettura negativa che ne aveva dato Calpurnia, e così
offre a Cesare quel buon auspicio che cercava fin dall’inizio della scena. Cesare ci crede. E
l’interpretazione di Decio rende possibile l’azione progettata dai congiurati.
80 II, ii, 127 In tutto questo scambio, Cesare appare ingenuo, indifeso, e anche generoso e pronto ad
ascoltare le ragioni degli altri. La hybris del potere si alterna in lui alla gentilezza e alla amichevolezza.
Questi tratti contraddittori del personaggio Shakespeare poté ricavarli in buona parte dal complesso
ritratto che ne fa Plutarco.
81 II, ii, 128 Sono come amici, ma presto si riveleranno tutt’altro che amici. L’ossessione del sembrare
e dell’essere, in Bruto, anticipa già il grande tema della finzione universale che sarà vissuto da
Amleto. E si ripresenta qui, ancora una volta, il contrasto irriducibile tra amicizia e ragione politica.
82 II, iii, 12-13 Per bocca di Artemidoro, emerge la prospettiva di quanti sono fedeli a Cesare e
credono nella sua virtù politica. E tutto questo avviene nel momento stesso in cui Cesare sta
andando verso la sua morte.