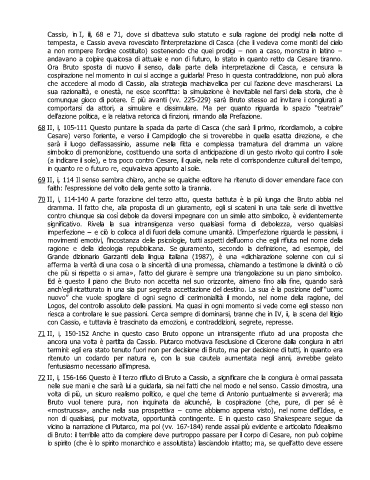Page 2280 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2280
Cassio, in I, iii, 68 e 71, dove si dibatteva sullo statuto e sulla ragione dei prodigi nella notte di
tempesta, e Cassio aveva rovesciato l’interpretazione di Casca (che li vedeva come moniti del cielo
a non rompere l’ordine costituito) sostenendo che quei prodigi − non a caso, monstra in latino −
andavano a colpire qualcosa di attuale e non di futuro, lo stato in quanto retto da Cesare tiranno.
Ora Bruto sposta di nuovo il senso, dalla parte della interpretazione di Casca, e censura la
cospirazione nel momento in cui si accinge a guidarla! Preso in questa contraddizione, non può allora
che accedere al modo di Cassio, alla strategia machiavellica per cui l’azione deve mascherarsi. La
sua razionalità, e onestà, ne esce sconfitta: la simulazione è inevitabile nel farsi della storia, che è
comunque gioco di potere. E più avanti (vv. 225-229) sarà Bruto stesso ad invitare i congiurati a
comportarsi da attori, a simulare e dissimulare. Ma per quanto riguarda lo spazio “teatrale”
dell’azione politica, e la relativa retorica di finzioni, rimando alla Prefazione.
68 II, i, 105-111 Questo puntare la spada da parte di Casca (che sarà il primo, ricordiamolo, a colpire
Cesare) verso l’oriente, e verso il Campidoglio che si troverebbe in quella esatta direzione, e che
sarà il luogo dell’assassinio, assume nella fitta e complessa tramatura del dramma un valore
simbolico di premonizione, costituendo una sorta di anticipazione di un gesto rivolto qui contro il sole
(a indicare il sole), e tra poco contro Cesare, il quale, nella rete di corrispondenze culturali del tempo,
in quanto re o futuro re, equivaleva appunto al sole.
69 II, i, 114 Il senso sembra chiaro, anche se qualche editore ha ritenuto di dover emendare face con
faith: l’espressione del volto della gente sotto la tirannia.
70 II, i, 114-140 A parte l’orazione del terzo atto, questa battuta è la più lunga che Bruto abbia nel
dramma. Il fatto che, alla proposta di un giuramento, egli si scateni in una tale serie di invettive
contro chiunque sia così debole da doversi impegnare con un simile atto simbolico, è evidentemente
significativo. Rivela la sua intransigenza verso qualsiasi forma di debolezza, verso qualsiasi
imperfezione − e ciò lo colloca al di fuori della comune umanità. L’imperfezione riguarda le passioni, i
movimenti emotivi, l’incostanza delle psicologie, tutti aspetti dell’uomo che egli rifiuta nel nome della
ragione e della ideologia repubblicana. Se giuramento, secondo la definizione, ad esempio, del
Grande dizionario Garzanti della lingua italiana (1987), è una «dichiarazione solenne con cui si
afferma la verità di una cosa o la sincerità di una promessa, chiamando a testimone la divinità o ciò
che più si rispetta o si ama», l’atto del giurare è sempre una triangolazione su un piano simbolico.
Ed è questo il piano che Bruto non accetta nel suo orizzonte, almeno fino alla fine, quando sarà
anch’egli ricatturato in una sia pur segreta accettazione del destino. La sua è la posizione dell’“uomo
nuovo” che vuole spogliare di ogni segno di cerimonialità il mondo, nel nome della ragione, del
Logos, del controllo assoluto delle passioni. Ma quasi in ogni momento si vede come egli stesso non
riesca a controllare le sue passioni. Cerca sempre di dominarsi, tranne che in IV, ii, la scena del litigio
con Cassio, e tuttavia è trascinato da emozioni, e contraddizioni, segrete, represse.
71 II, i, 150-152 Anche in questo caso Bruto oppone un intransigente rifiuto ad una proposta che
ancora una volta è partita da Cassio. Plutarco motivava l’esclusione di Cicerone dalla congiura in altri
termini: egli era stato tenuto fuori non per decisione di Bruto, ma per decisione di tutti, in quanto era
ritenuto un codardo per natura e, con la sua cautela aumentata negli anni, avrebbe gelato
l’entusiasmo necessario all’impresa.
72 II, i, 156-166 Questo è il terzo rifiuto di Bruto a Cassio, a significare che la congiura è ormai passata
nelle sue mani e che sarà lui a guidarla, sia nei fatti che nel modo e nel senso. Cassio dimostra, una
volta di più, un sicuro realismo politico, e quel che teme di Antonio puntualmente si avvererà; ma
Bruto vuol tenere pura, non inquinata da alcunché, la cospirazione (che, pure, di per sé è
«mostruosa», anche nella sua prospettiva − come abbiamo appena visto), nel nome dell’Idea, e
non di qualsiasi, pur motivata, opportunità contingente. E in questo caso Shakespeare segue da
vicino la narrazione di Plutarco, ma poi (vv. 167-184) rende assai più evidente e articolato l’idealismo
di Bruto: il terribile atto da compiere deve purtroppo passare per il corpo di Cesare, non può colpirne
lo spirito (che è lo spirito monarchico e assolutista) lasciandolo intatto; ma, se quell’atto deve essere