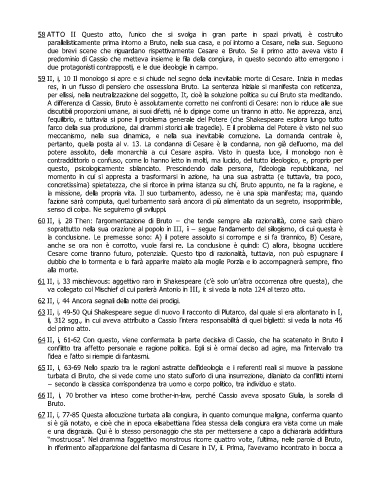Page 2279 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2279
58 ATTO II Questo atto, l’unico che si svolga in gran parte in spazi privati, è costruito
parallelisticamente prima intorno a Bruto, nella sua casa, e poi intorno a Cesare, nella sua. Seguono
due brevi scene che riguardano rispettivamente Cesare e Bruto. Se il primo atto aveva visto il
predominio di Cassio che metteva insieme le fila della congiura, in questo secondo atto emergono i
due protagonisti contrapposti, e le due ideologie in campo.
59 II, i, 10 Il monologo si apre e si chiude nel segno della inevitabile morte di Cesare. Inizia in medias
res, in un flusso di pensiero che ossessiona Bruto. La sentenza iniziale si manifesta con reticenza,
per ellissi, nella neutralizzazione del soggetto, It, cioè la soluzione politica su cui Bruto sta meditando.
A differenza di Cassio, Bruto è assolutamente corretto nei confronti di Cesare: non lo riduce alle sue
discutibili proporzioni umane, ai suoi difetti, né lo dipinge come un tiranno in atto. Ne apprezza, anzi,
l’equilibrio, e tuttavia si pone il problema generale del Potere (che Shakespeare esplora lungo tutto
l’arco della sua produzione, dai drammi storici alle tragedie). E il problema del Potere è visto nel suo
meccanismo, nella sua dinamica, e nella sua inevitabile corruzione. La domanda centrale è,
pertanto, quella posta al v. 13. La condanna di Cesare è la condanna, non già dell’uomo, ma del
potere assoluto, della monarchia a cui Cesare aspira. Visto in questa luce, il monologo non è
contraddittorio o confuso, come lo hanno letto in molti, ma lucido, del tutto ideologico, e, proprio per
questo, psicologicamente sbilanciato. Prescindendo dalla persona, l’ideologia repubblicana, nel
momento in cui si appresta a trasformarsi in azione, ha una sua astratta (e tuttavia, tra poco,
concretissima) spietatezza, che si ritorce in prima istanza su chi, Bruto appunto, ne fa la ragione, e
la missione, della propria vita. Il suo turbamento, adesso, ne è una spia manifesta; ma, quando
l’azione sarà compiuta, quel turbamento sarà ancora di più alimentato da un segreto, insopprimibile,
senso di colpa. Ne seguiremo gli sviluppi.
60 II, i, 28 Then: l’argomentazione di Bruto − che tende sempre alla razionalità, come sarà chiaro
soprattutto nella sua orazione al popolo in III, ii − segue l’andamento del sillogismo, di cui questa è
la conclusione. Le premesse sono: A) il potere assoluto si corrompe e si fa tirannico, B) Cesare,
anche se ora non è corrotto, vuole farsi re. La conclusione è quindi: C) allora, bisogna uccidere
Cesare come tiranno futuro, potenziale. Questo tipo di razionalità, tuttavia, non può espugnare il
dubbio che lo tormenta e lo farà apparire malato alla moglie Porzia e lo accompagnerà sempre, fino
alla morte.
61 II, i, 33 mischievous: aggettivo raro in Shakespeare (c’è solo un’altra occorrenza oltre questa), che
va collegato col Mischief di cui parlerà Antonio in III, ii: si veda la nota 124 al terzo atto.
62 II, i, 44 Ancora segnali della notte dei prodigi.
63 II, i, 49-50 Qui Shakespeare segue di nuovo il racconto di Plutarco, dal quale si era allontanato in I,
ii, 312 sgg., in cui aveva attribuito a Cassio l’intera responsabilità di quei biglietti: si veda la nota 46
del primo atto.
64 II, i, 61-62 Con questo, viene confermata la parte decisiva di Cassio, che ha scatenato in Bruto il
conflitto tra affetto personale e ragione politica. Egli si è ormai deciso ad agire, ma l’intervallo tra
l’idea e l’atto si riempie di fantasmi.
65 II, i, 63-69 Nello spazio tra le ragioni astratte dell’ideologia e i referenti reali si muove la passione
turbata di Bruto, che si vede come uno stato sull’orlo di una insurrezione, dilaniato da conflitti interni
− secondo la classica corrispondenza tra uomo e corpo politico, tra individuo e stato.
66 II, i, 70 brother va inteso come brother-in-law, perché Cassio aveva sposato Giulia, la sorella di
Bruto.
67 II, i, 77-85 Questa allocuzione turbata alla congiura, in quanto comunque maligna, conferma quanto
si è già notato, e cioè che in epoca elisabettiana l’idea stessa della congiura era vista come un male
e una disgrazia. Qui è lo stesso personaggio che sta per mettersene a capo a dichiararla addirittura
“mostruosa”. Nel dramma l’aggettivo monstrous ricorre quattro volte, l’ultima, nelle parole di Bruto,
in riferimento all’apparizione del fantasma di Cesare in IV, ii. Prima, l’avevamo incontrato in bocca a