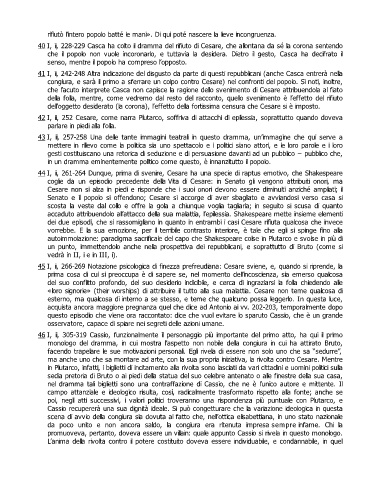Page 2277 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2277
rifiutò l’intero popolo batté le mani». Di qui poté nascere la lieve incongruenza.
40 I, ii, 228-229 Casca ha colto il dramma del rifiuto di Cesare, che allontana da sé la corona sentendo
che il popolo non vuole incoronarlo, e tuttavia la desidera. Dietro il gesto, Casca ha decifrato il
senso, mentre il popolo ha compreso l’opposto.
41 I, ii, 242-248 Altra indicazione del disgusto da parte di questi repubblicani (anche Casca entrerà nella
congiura, e sarà il primo a sferrare un colpo contro Cesare) nei confronti del popolo. Si noti, inoltre,
che l’acuto interprete Casca non capisce la ragione dello svenimento di Cesare attribuendola al fiato
della folla, mentre, come vedremo dal resto del racconto, quello svenimento è l’effetto del rifiuto
dell’oggetto desiderato (la corona), l’effetto della fortissima censura che Cesare si è imposto.
42 I, ii, 252 Cesare, come narra Plutarco, soffriva di attacchi di epilessia, soprattutto quando doveva
parlare in piedi alla folla.
43 I, ii, 257-258 Una delle tante immagini teatrali in questo dramma, un’immagine che qui serve a
mettere in rilievo come la politica sia uno spettacolo e i politici siano attori, e le loro parole e i loro
gesti costituiscano una retorica di seduzione e di persuasione davanti ad un pubblico − pubblico che,
in un dramma eminentemente politico come questo, è innanzitutto il popolo.
44 I, ii, 261-264 Dunque, prima di svenire, Cesare ha una specie di raptus emotivo, che Shakespeare
coglie da un episodio precedente della Vita di Cesare: in Senato gli vengono attribuiti onori, ma
Cesare non si alza in piedi e risponde che i suoi onori devono essere diminuiti anziché ampliati; il
Senato e il popolo si offendono; Cesare si accorge di aver sbagliato e avviandosi verso casa si
scosta la veste dal collo e offre la gola a chiunque voglia tagliarla; in seguito si scusa di quanto
accaduto attribuendolo all’attacco della sua malattia, l’epilessia. Shakespeare mette insieme elementi
dei due episodi, che si rassomigliano in quanto in entrambi i casi Cesare rifiuta qualcosa che invece
vorrebbe. E la sua emozione, per il terribile contrasto interiore, è tale che egli si spinge fino alla
autoimmolazione: paradigma sacrificale del capo che Shakespeare colse in Plutarco e svolse in più di
un punto, immettendolo anche nella prospettiva dei repubblicani, e soprattutto di Bruto (come si
vedrà in II, i e in III, i).
45 I, ii, 266-269 Notazione psicologica di finezza prefreudiana: Cesare sviene, e, quando si riprende, la
prima cosa di cui si preoccupa è di sapere se, nel momento dell’incoscienza, sia emerso qualcosa
del suo conflitto profondo, del suo desiderio indicibile, e cerca di ingraziarsi la folla chiedendo alle
«loro signorie» (their worships) di attribuire il tutto alla sua malattia. Cesare non teme qualcosa di
esterno, ma qualcosa di interno a se stesso, e teme che qualcuno possa leggerlo. In questa luce,
acquista ancora maggiore pregnanza quel che dice ad Antonio ai vv. 202-203, temporalmente dopo
questo episodio che viene ora raccontato: dice che vuol evitare lo sparuto Cassio, che è un grande
osservatore, capace di spiare nei segreti delle azioni umane.
46 I, ii, 305-319 Cassio, funzionalmente il personaggio più importante del primo atto, ha qui il primo
monologo del dramma, in cui mostra l’aspetto non nobile della congiura in cui ha attirato Bruto,
facendo trapelare le sue motivazioni personali. Egli rivela di essere non solo uno che sa “sedurre”,
ma anche uno che sa montare ad arte, con la sua propria iniziativa, la rivolta contro Cesare. Mentre
in Plutarco, infatti, i biglietti di incitamento alla rivolta sono lasciati da vari cittadini e uomini politici sulla
sedia pretoria di Bruto o ai piedi della statua del suo celebre antenato o alle finestre della sua casa,
nel dramma tali biglietti sono una contraffazione di Cassio, che ne è l’unico autore e mittente. Il
campo attanziale e ideologico risulta, così, radicalmente trasformato rispetto alla fonte; anche se
poi, negli atti successivi, i valori politici troveranno una rispondenza più puntuale con Plutarco, e
Cassio recupererà una sua dignità ideale. Si può congetturare che la variazione ideologica in questa
scena di avvio della congiura sia dovuta al fatto che, nell’ottica elisabettiana, in uno stato nazionale
da poco unito e non ancora saldo, la congiura era ritenuta impresa sempre infame. Chi la
promuoveva, pertanto, doveva essere un villain: quale appunto Cassio si rivela in questo monologo.
L’anima della rivolta contro il potere costituito doveva essere individuabile, e condannabile, in quel