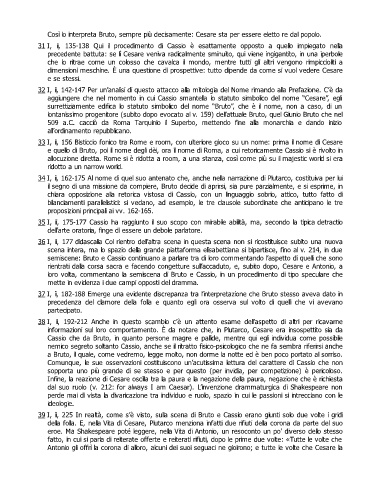Page 2276 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2276
Così lo interpreta Bruto, sempre più decisamente: Cesare sta per essere eletto re dal popolo.
31 I, ii, 135-138 Qui il procedimento di Cassio è esattamente opposto a quello impiegato nella
precedente battuta: se lì Cesare veniva radicalmente sminuito, qui viene ingigantito, in una iperbole
che lo ritrae come un colosso che cavalca il mondo, mentre tutti gli altri vengono rimpiccioliti a
dimensioni meschine. È una questione di prospettive: tutto dipende da come si vuol vedere Cesare
e se stessi.
32 I, ii, 142-147 Per un’analisi di questo attacco alla mitologia del Nome rimando alla Prefazione. C’è da
aggiungere che nel momento in cui Cassio smantella lo statuto simbolico del nome “Cesare”, egli
surrettiziamente edifica lo statuto simbolico del nome “Bruto”, che è il nome, non a caso, di un
lontanissimo progenitore (subito dopo evocato al v. 159) dell’attuale Bruto, quel Giunio Bruto che nel
509 a.C. cacciò da Roma Tarquinio il Superbo, mettendo fine alla monarchia e dando inizio
all’ordinamento repubblicano.
33 I, ii, 156 Bisticcio fonico tra Rome e room, con ulteriore gioco su un nome: prima il nome di Cesare
e quello di Bruto, poi il nome degli dèi, ora il nome di Roma, a cui retoricamente Cassio si è rivolto in
allocuzione diretta. Rome si è ridotta a room, a una stanza, così come più su il majestic world si era
ridotto a un narrow world.
34 I, ii, 162-175 Al nome di quel suo antenato che, anche nella narrazione di Plutarco, costituiva per lui
il segno di una missione da compiere, Bruto decide di aprirsi, sia pure parzialmente, e si esprime, in
chiara opposizione alla retorica vistosa di Cassio, con un linguaggio sobrio, attico, tutto fatto di
bilanciamenti parallelistici: si vedano, ad esempio, le tre clausole subordinate che anticipano le tre
proposizioni principali ai vv. 162-165.
35 I, ii, 175-177 Cassio ha raggiunto il suo scopo con mirabile abilità, ma, secondo la tipica detractio
dell’arte oratoria, finge di essere un debole parlatore.
36 I, ii, 177 didascalia Col rientro dell’altra scena in questa scena non si ricostituisce subito una nuova
scena intera, ma lo spazio della grande piattaforma elisabettiana si bipartisce, fino al v. 214, in due
semiscene: Bruto e Cassio continuano a parlare tra di loro commentando l’aspetto di quelli che sono
rientrati dalla corsa sacra e facendo congetture sull’accaduto, e, subito dopo, Cesare e Antonio, a
loro volta, commentano la semiscena di Bruto e Cassio, in un procedimento di tipo speculare che
mette in evidenza i due campi opposti del dramma.
37 I, ii, 182-188 Emerge una evidente discrepanza tra l’interpretazione che Bruto stesso aveva dato in
precedenza del clamore della folla e quanto egli ora osserva sul volto di quelli che vi avevano
partecipato.
38 I, ii, 192-212 Anche in questo scambio c’è un attento esame dell’aspetto di altri per ricavarne
informazioni sul loro comportamento. È da notare che, in Plutarco, Cesare era insospettito sia da
Cassio che da Bruto, in quanto persone magre e pallide, mentre qui egli individua come possibile
nemico segreto soltanto Cassio, anche se il ritratto fisico-psicologico che ne fa sembra riferirsi anche
a Bruto, il quale, come vedremo, legge molto, non dorme la notte ed è ben poco portato al sorriso.
Comunque, le sue osservazioni costituiscono un’acutissima lettura del carattere di Cassio che non
sopporta uno più grande di se stesso e per questo (per invidia, per competizione) è pericoloso.
Infine, la reazione di Cesare oscilla tra la paura e la negazione della paura, negazione che è richiesta
dal suo ruolo (v. 212: for always I am Caesar). L’invenzione drammaturgica di Shakespeare non
perde mai di vista la divaricazione tra individuo e ruolo, spazio in cui le passioni si intrecciano con le
ideologie.
39 I, ii, 225 In realtà, come s’è visto, sulla scena di Bruto e Cassio erano giunti solo due volte i gridi
della folla. E, nella Vita di Cesare, Plutarco menziona infatti due rifiuti della corona da parte del suo
eroe. Ma Shakespeare poté leggere, nella Vita di Antonio, un resoconto un po’ diverso dello stesso
fatto, in cui si parla di reiterate offerte e reiterati rifiuti, dopo le prime due volte: «Tutte le volte che
Antonio gli offrì la corona di alloro, alcuni dei suoi seguaci ne gioirono; e tutte le volte che Cesare la