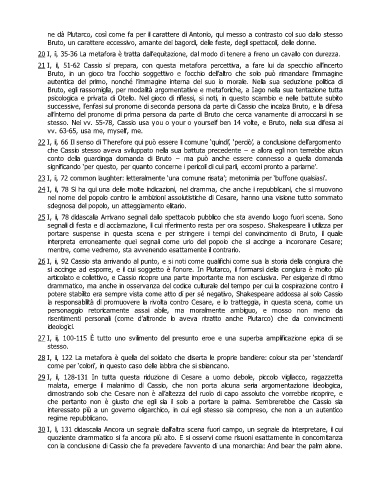Page 2275 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2275
ne dà Plutarco, così come fa per il carattere di Antonio, qui messo a contrasto col suo dallo stesso
Bruto, un carattere eccessivo, amante dei bagordi, delle feste, degli spettacoli, delle donne.
20 I, ii, 35-36 La metafora è tratta dall’equitazione, dal modo di tenere a freno un cavallo con durezza.
21 I, ii, 51-62 Cassio si prepara, con questa metafora percettiva, a fare lui da specchio all’incerto
Bruto, in un gioco tra l’occhio soggettivo e l’occhio dell’altro che solo può rimandare l’immagine
autentica del primo, nonché l’immagine interna del suo io morale. Nella sua seduzione politica di
Bruto, egli rassomiglia, per modalità argomentative e metaforiche, a Iago nella sua tentazione tutta
psicologica e privata di Otello. Nel gioco di riflessi, si noti, in questo scambio e nelle battute subito
successive, l’enfasi sul pronome di seconda persona da parte di Cassio che incalza Bruto, e la difesa
all’interno del pronome di prima persona da parte di Bruto che cerca vanamente di arroccarsi in se
stesso. Nei vv. 55-78, Cassio usa you o your o yourself ben 14 volte, e Bruto, nella sua difesa ai
vv. 63-65, usa me, myself, me.
22 I, ii, 66 Il senso di Therefore qui può essere il comune ‘quindi’, ‘perciò’, a conclusione dell’argomento
che Cassio stesso aveva sviluppato nella sua battuta precedente − e allora egli non terrebbe alcun
conto della guardinga domanda di Bruto − ma può anche essere connesso a quella domanda
significando ‘per questo, per quanto concerne i pericoli di cui parli, eccomi pronto a parlarne’.
23 I, ii, 72 common laughter: letteralmente ‘una comune risata’; metonimia per ‘buffone qualsiasi’.
24 I, ii, 78 Si ha qui una delle molte indicazioni, nel dramma, che anche i repubblicani, che si muovono
nel nome del popolo contro le ambizioni assolutistiche di Cesare, hanno una visione tutto sommato
sdegnosa del popolo, un atteggiamento elitario.
25 I, ii, 78 didascalia Arrivano segnali dallo spettacolo pubblico che sta avendo luogo fuori scena. Sono
segnali di festa e di acclamazione, il cui riferimento resta per ora sospeso. Shakespeare li utilizza per
portare suspense in questa scena e per stringere i tempi del convincimento di Bruto, il quale
interpreta erroneamente quei segnali come urlo del popolo che si accinge a incoronare Cesare;
mentre, come vedremo, sta avvenendo esattamente il contrario.
26 I, ii, 92 Cassio sta arrivando al punto, e si noti come qualifichi come sua la storia della congiura che
si accinge ad esporre, e il cui soggetto è l’onore. In Plutarco, il formarsi della congiura è molto più
articolato e collettivo, e Cassio ricopre una parte importante ma non esclusiva. Per esigenze di ritmo
drammatico, ma anche in osservanza del codice culturale del tempo per cui la cospirazione contro il
potere stabilito era sempre vista come atto di per sé negativo, Shakespeare addossa al solo Cassio
la responsabilità di promuovere la rivolta contro Cesare, e lo tratteggia, in questa scena, come un
personaggio retoricamente assai abile, ma moralmente ambiguo, e mosso non meno da
risentimenti personali (come d’altronde lo aveva ritratto anche Plutarco) che da convincimenti
ideologici.
27 I, ii, 100-115 È tutto uno svilimento del presunto eroe e una superba amplificazione epica di se
stesso.
28 I, ii, 122 La metafora è quella del soldato che diserta le proprie bandiere: colour sta per ‘stendardi’
come per ‘colori’, in questo caso delle labbra che si sbiancano.
29 I, ii, 128-131 In tutta questa riduzione di Cesare a uomo debole, piccolo vigliacco, ragazzetta
malata, emerge il malanimo di Cassio, che non porta alcuna seria argomentazione ideologica,
dimostrando solo che Cesare non è all’altezza del ruolo di capo assoluto che vorrebbe ricoprire, e
che pertanto non è giusto che egli sia il solo a portare la palma. Sembrerebbe che Cassio sia
interessato più a un governo oligarchico, in cui egli stesso sia compreso, che non a un autentico
regime repubblicano.
30 I, ii, 131 didascalia Ancora un segnale dall’altra scena fuori campo, un segnale da interpretare, il cui
quoziente drammatico si fa ancora più alto. E si osservi come risuoni esattamente in concomitanza
con la conclusione di Cassio che fa prevedere l’avvento di una monarchia: And bear the palm alone.