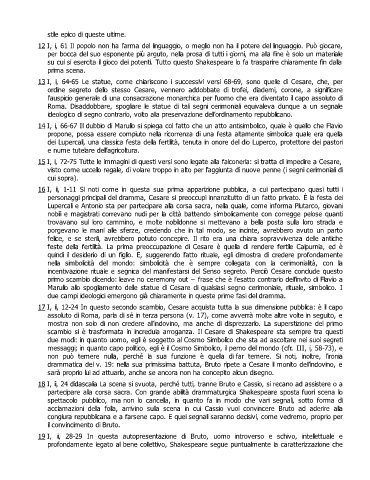Page 2274 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2274
stile epico di queste ultime.
12 I, i, 61 Il popolo non ha l’arma del linguaggio, o meglio non ha il potere del linguaggio. Può giocare,
per bocca del suo esponente più arguto, nella prosa di tutti i giorni, ma alla fine è solo un materiale
su cui si esercita il gioco dei potenti. Tutto questo Shakespeare lo fa trasparire chiaramente fin dalla
prima scena.
13 I, i, 64-65 Le statue, come chiariscono i successivi versi 68-69, sono quelle di Cesare, che, per
ordine segreto dello stesso Cesare, vennero addobbate di trofei, diademi, corone, a significare
l’auspicio generale di una consacrazione monarchica per l’uomo che era diventato il capo assoluto di
Roma. Disaddobbare, spogliare le statue di tali segni cerimoniali equivaleva dunque a un segnale
ideologico di segno contrario, volto alla preservazione dell’ordinamento repubblicano.
14 I, i, 66-67 Il dubbio di Marullo si spiega col fatto che un atto antisimbolico, quale è quello che Flavio
propone, possa essere compiuto nella ricorrenza di una festa altamente simbolica quale era quella
dei Lupercali, una classica festa della fertilità, tenuta in onore del dio Luperco, protettore dei pastori
e nume tutelare dell’agricoltura.
15 I, i, 72-75 Tutte le immagini di questi versi sono legate alla falconeria: si tratta di impedire a Cesare,
visto come uccello regale, di volare troppo in alto per l’aggiunta di nuove penne (i segni cerimoniali di
cui sopra).
16 I, ii, 1-11 Si noti come in questa sua prima apparizione pubblica, a cui partecipano quasi tutti i
personaggi principali del dramma, Cesare si preoccupi innanzitutto di un fatto privato. È la festa dei
Lupercali e Antonio sta per partecipare alla corsa sacra, nella quale, come informa Plutarco, giovani
nobili e magistrati correvano nudi per la città battendo simbolicamente con corregge pelose quanti
trovavano sul loro cammino, e molte nobildonne si mettevano a bella posta sulla loro strada e
porgevano le mani alle sferze, credendo che in tal modo, se incinte, avrebbero avuto un parto
felice, e se sterili, avrebbero potuto concepire. Il rito era una chiara sopravvivenza delle antiche
feste della fertilità. La prima preoccupazione di Cesare è quella di rendere fertile Calpurnia, ed è
quindi il desiderio di un figlio. E, suggerendo l’atto rituale, egli dimostra di credere profondamente
nella simbolicità del mondo: simbolicità che è sempre collegata con la cerimonialità, con la
incentivazione rituale e segnica del manifestarsi del Senso segreto. Perciò Cesare conclude questo
primo scambio dicendo: leave no ceremony out − frase che è l’esatto contrario dell’invito di Flavio a
Marullo allo spogliamento delle statue di Cesare di qualsiasi segno cerimoniale, rituale, simbolico. I
due campi ideologici emergono già chiaramente in queste prime fasi del dramma.
17 I, ii, 12-24 In questo secondo scambio, Cesare acquista tutta la sua dimensione pubblica: è il capo
assoluto di Roma, parla di sé in terza persona (v. 17), come avverrà molte altre volte in seguito, e
mostra non solo di non credere all’indovino, ma anche di disprezzarlo. La superstizione del primo
scambio si è trasformata in incredula arroganza. Il Cesare di Shakespeare sta sempre tra questi
due modi: in quanto uomo, egli è soggetto al Cosmo Simbolico che sta ad ascoltare nei suoi segreti
messaggi; in quanto capo politico, egli è il Cosmo Simbolico, il perno del mondo (cfr. III, i, 58-73), e
non può temere nulla, perché la sua funzione è quella di far temere. Si noti, inoltre, l’ironia
drammatica del v. 19: nella sua primissima battuta, Bruto ripete a Cesare il monito dell’indovino, e
sarà proprio lui ad attuarlo, anche se ancora non ha concepito alcun disegno.
18 I, ii, 24 didascalia La scena si svuota, perché tutti, tranne Bruto e Cassio, si recano ad assistere o a
partecipare alla corsa sacra. Con grande abilità drammaturgica Shakespeare sposta fuori scena lo
spettacolo pubblico, ma non lo cancella, in quanto fa in modo che vari segnali, sotto forma di
acclamazioni della folla, arrivino sulla scena in cui Cassio vuol convincere Bruto ad aderire alla
congiura repubblicana e a farsene capo. E quei segnali saranno decisivi, come vedremo, proprio per
il convincimento di Bruto.
19 I, ii, 28-29 In questa autopresentazione di Bruto, uomo introverso e schivo, intellettuale e
profondamente legato al bene collettivo, Shakespeare segue puntualmente la caratterizzazione che