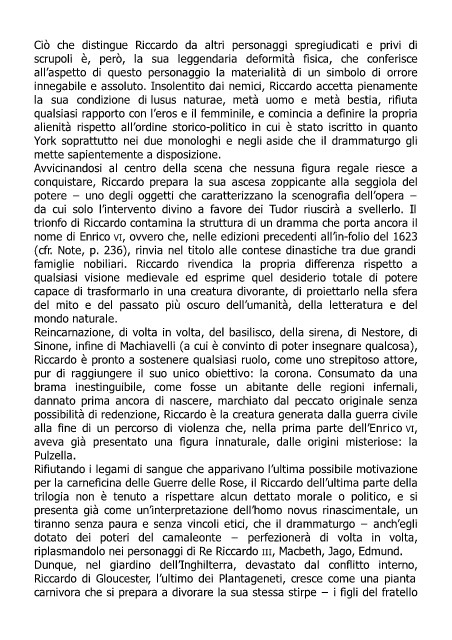Page 639 - Shakespeare - Vol. 1
P. 639
Ciò che distingue Riccardo da altri personaggi spregiudicati e privi di
scrupoli è, però, la sua leggendaria deformità fisica, che conferisce
all’aspetto di questo personaggio la materialità di un simbolo di orrore
innegabile e assoluto. Insolentito dai nemici, Riccardo accetta pienamente
la sua condizione di lusus naturae, metà uomo e metà bestia, rifiuta
qualsiasi rapporto con l’eros e il femminile, e comincia a definire la propria
alienità rispetto all’ordine storico-politico in cui è stato iscritto in quanto
York soprattutto nei due monologhi e negli aside che il drammaturgo gli
mette sapientemente a disposizione.
Avvicinandosi al centro della scena che nessuna figura regale riesce a
conquistare, Riccardo prepara la sua ascesa zoppicante alla seggiola del
potere - uno degli oggetti che caratterizzano la scenografia dell’opera -
da cui solo l’intervento divino a favore dei Tudor riuscirà a svellerlo. Il
trionfo di Riccardo contamina la struttura di un dramma che porta ancora il
nome di Enrico VI, ovvero che, nelle edizioni precedenti all’in-folio del 1623
(cfr. Note, p. 236), rinvia nel titolo alle contese dinastiche tra due grandi
famiglie nobiliari. Riccardo rivendica la propria differenza rispetto a
qualsiasi visione medievale ed esprime quel desiderio totale di potere
capace di trasformarlo in una creatura divorante, di proiettarlo nella sfera
del mito e del passato più oscuro dell’umanità, della letteratura e del
mondo naturale.
Reincarnazione, di volta in volta, del basilisco, della sirena, di Nestore, di
Sinone, infine di Machiavelli (a cui è convinto di poter insegnare qualcosa),
Riccardo è pronto a sostenere qualsiasi ruolo, come uno strepitoso attore,
pur di raggiungere il suo unico obiettivo: la corona. Consumato da una
brama inestinguibile, come fosse un abitante delle regioni infernali,
dannato prima ancora di nascere, marchiato dal peccato originale senza
possibilità di redenzione, Riccardo è la creatura generata dalla guerra civile
alla fine di un percorso di violenza che, nella prima parte dell’Enrico VI,
aveva già presentato una figura innaturale, dalle origini misteriose: la
Pulzella.
Rifiutando i legami di sangue che apparivano l’ultima possibile motivazione
per la carneficina delle Guerre delle Rose, il Riccardo dell’ultima parte della
trilogia non è tenuto a rispettare alcun dettato morale o politico, e si
presenta già come un’interpretazione dell’homo novus rinascimentale, un
tiranno senza paura e senza vincoli etici, che il drammaturgo - anch’egli
dotato dei poteri del camaleonte - perfezionerà di volta in volta,
riplasmandolo nei personaggi di Re Riccardo III, Macbeth, Jago, Edmund.
Dunque, nel giardino dell’Inghilterra, devastato dal conflitto interno,
Riccardo di Gloucester, l’ultimo dei Plantageneti, cresce come una pianta
carnivora che si prepara a divorare la sua stessa stirpe - i figli del fratello