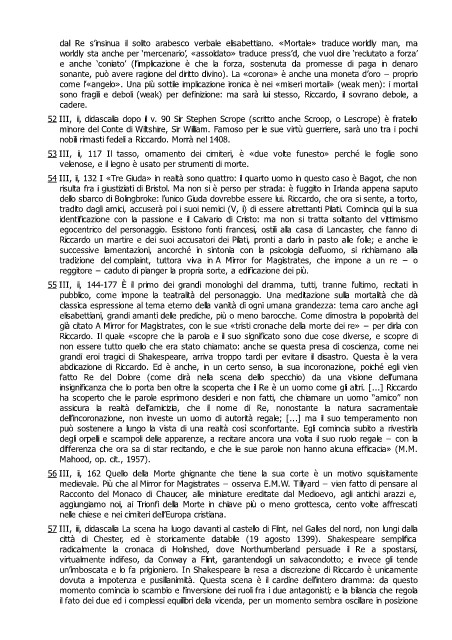Page 2972 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2972
dal Re s’insinua il solito arabesco verbale elisabettiano. «Mortale» traduce worldly man, ma
worldly sta anche per ‘mercenario’, «assoldato» traduce press’d, che vuol dire ‘reclutato a forza’
e anche ‘coniato’ (l’implicazione è che la forza, sostenuta da promesse di paga in denaro
sonante, può avere ragione del diritto divino). La «corona» è anche una moneta d’oro - proprio
come l’«angelo». Una più sottile implicazione ironica è nei «miseri mortali» (weak men): i mortali
sono fragili e deboli (weak) per definizione: ma sarà lui stesso, Riccardo, il sovrano debole, a
cadere.
52 III, ii, didascalia dopo il v. 90 Sir Stephen Scrope (scritto anche Scroop, o Lescrope) è fratello
minore del Conte di Wiltshire, Sir William. Famoso per le sue virtù guerriere, sarà uno tra i pochi
nobili rimasti fedeli a Riccardo. Morrà nel 1408.
53 III, ii, 117 Il tasso, ornamento dei cimiteri, è «due volte funesto» perché le foglie sono
velenose, e il legno è usato per strumenti di morte.
54 III, ii, 132 I «Tre Giuda» in realtà sono quattro: il quarto uomo in questo caso è Bagot, che non
risulta fra i giustiziati di Bristol. Ma non si è perso per strada: è fuggito in Irlanda appena saputo
dello sbarco di Bolingbroke: l’unico Giuda dovrebbe essere lui. Riccardo, che ora si sente, a torto,
tradito dagli amici, accuserà poi i suoi nemici (V, i) di essere altrettanti Pilati. Comincia qui la sua
identificazione con la passione e il Calvario di Cristo: ma non si tratta soltanto del vittimismo
egocentrico del personaggio. Esistono fonti francesi, ostili alla casa di Lancaster, che fanno di
Riccardo un martire e dei suoi accusatori dei Pilati, pronti a darlo in pasto alle folle; e anche le
successive lamentazioni, ancorché in sintonia con la psicologia dell’uomo, si richiamano alla
tradizione del complaint, tuttora viva in A Mirror for Magistrates, che impone a un re - o
reggitore - caduto di pianger la propria sorte, a edificazione dei più.
55 III, ii, 144-177 È il primo dei grandi monologhi del dramma, tutti, tranne l’ultimo, recitati in
pubblico, come impone la teatralità del personaggio. Una meditazione sulla mortalità che dà
classica espressione al tema eterno della vanità di ogni umana grandezza: tema caro anche agli
elisabettiani, grandi amanti delle prediche, più o meno barocche. Come dimostra la popolarità del
già citato A Mirror for Magistrates, con le sue «tristi cronache della morte dei re» - per dirla con
Riccardo. Il quale «scopre che la parola e il suo significato sono due cose diverse, e scopre di
non essere tutto quello che era stato chiamato: anche se questa presa di coscienza, come nei
grandi eroi tragici di Shakespeare, arriva troppo tardi per evitare il disastro. Questa è la vera
abdicazione di Riccardo. Ed è anche, in un certo senso, la sua incoronazione, poiché egli vien
fatto Re del Dolore (come dirà nella scena dello specchio) da una visione dell’umana
insignificanza che lo porta ben oltre la scoperta che il Re è un uomo come gli altri. [...] Riccardo
ha scoperto che le parole esprimono desideri e non fatti, che chiamare un uomo “amico” non
assicura la realtà dell’amicizia, che il nome di Re, nonostante la natura sacramentale
dell’incoronazione, non investe un uomo di autorità regale; [...] ma il suo temperamento non
può sostenere a lungo la vista di una realtà così sconfortante. Egli comincia subito a rivestirla
degli orpelli e scampoli delle apparenze, a recitare ancora una volta il suo ruolo regale - con la
differenza che ora sa di star recitando, e che le sue parole non hanno alcuna efficacia» (M.M.
Mahood, op. cit., 1957).
56 III, ii, 162 Quello della Morte ghignante che tiene la sua corte è un motivo squisitamente
medievale. Più che al Mirror for Magistrates - osserva E.M.W. Tillyard - vien fatto di pensare al
Racconto del Monaco di Chaucer, alle miniature ereditate dal Medioevo, agli antichi arazzi e,
aggiungiamo noi, ai Trionfi della Morte in chiave più o meno grottesca, cento volte affrescati
nelle chiese e nei cimiteri dell’Europa cristiana.
57 III, iii, didascalia La scena ha luogo davanti al castello di Flint, nel Galles del nord, non lungi dalla
città di Chester, ed è storicamente databile (19 agosto 1399). Shakespeare semplifica
radicalmente la cronaca di Holinshed, dove Northumberland persuade il Re a spostarsi,
virtualmente indifeso, da Conway a Flint, garantendogli un salvacondotto; e invece gli tende
un’imboscata e lo fa prigioniero. In Shakespeare la resa a discrezione di Riccardo è unicamente
dovuta a impotenza e pusillanimità. Questa scena è il cardine dell’intero dramma: da questo
momento comincia lo scambio e l’inversione dei ruoli fra i due antagonisti; e la bilancia che regola
il fato dei due ed i complessi equilibri della vicenda, per un momento sembra oscillare in posizione