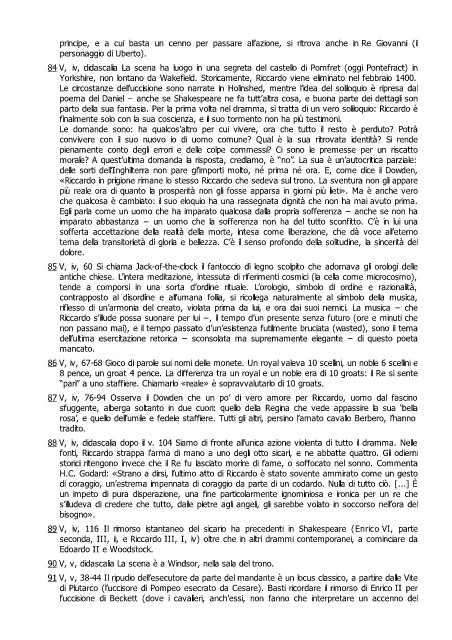Page 2976 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2976
principe, e a cui basta un cenno per passare all’azione, si ritrova anche in Re Giovanni (il
personaggio di Uberto).
84 V, iv, didascalia La scena ha luogo in una segreta del castello di Pomfret (oggi Pontefract) in
Yorkshire, non lontano da Wakefield. Storicamente, Riccardo viene eliminato nel febbraio 1400.
Le circostanze dell’uccisione sono narrate in Holinshed, mentre l’idea del soliloquio è ripresa dal
poema del Daniel - anche se Shakespeare ne fa tutt’altra cosa, e buona parte dei dettagli son
parto della sua fantasia. Per la prima volta nel dramma, si tratta di un vero soliloquio: Riccardo è
finalmente solo con la sua coscienza, e il suo tormento non ha più testimoni.
Le domande sono: ha qualcos’altro per cui vivere, ora che tutto il resto è perduto? Potrà
convivere con il suo nuovo io di uomo comune? Qual è la sua ritrovata identità? Si rende
pienamente conto degli errori e delle colpe commessi? Ci sono le premesse per un riscatto
morale? A quest’ultima domanda la risposta, crediamo, è “no”. La sua è un’autocritica parziale:
delle sorti dell’Inghilterra non pare gl’importi molto, né prima né ora. E, come dice il Dowden,
«Riccardo in prigione rimane lo stesso Riccardo che sedeva sul trono. La sventura non gli appare
più reale ora di quanto la prosperità non gli fosse apparsa in giorni più lieti». Ma è anche vero
che qualcosa è cambiato: il suo eloquio ha una rassegnata dignità che non ha mai avuto prima.
Egli parla come un uomo che ha imparato qualcosa dalla propria sofferenza - anche se non ha
imparato abbastanza - un uomo che la sofferenza non ha del tutto sconfitto. C’è in lui una
sofferta accettazione della realtà della morte, intesa come liberazione, che dà voce all’eterno
tema della transitorietà di gloria e bellezza. C’è il senso profondo della solitudine, la sincerità del
dolore.
85 V, iv, 60 Si chiama Jack-of-the-clock il fantoccio di legno scolpito che adornava gli orologi delle
antiche chiese. L’intera meditazione, intessuta di riferimenti cosmici (la cella come microcosmo),
tende a comporsi in una sorta d’ordine rituale. L’orologio, simbolo di ordine e razionalità,
contrapposto al disordine e all’umana follia, si ricollega naturalmente al simbolo della musica,
riflesso di un’armonia del creato, violata prima da lui, e ora dai suoi nemici. La musica - che
Riccardo s’illude possa suonare per lui -, il tempo d’un presente senza futuro (ore e minuti che
non passano mai), e il tempo passato d’un’esistenza futilmente bruciata (wasted), sono il tema
dell’ultima esercitazione retorica - sconsolata ma supremamente elegante - di questo poeta
mancato.
86 V, iv, 67-68 Gioco di parole sui nomi delle monete. Un royal valeva 10 scellini, un noble 6 scellini e
8 pence, un groat 4 pence. La differenza tra un royal e un noble era di 10 groats: il Re si sente
“pari” a uno staffiere. Chiamarlo «reale» è sopravvalutarlo di 10 groats.
87 V, iv, 76-94 Osserva il Dowden che un po’ di vero amore per Riccardo, uomo dal fascino
sfuggente, alberga soltanto in due cuori: quello della Regina che vede appassire la sua ‘bella
rosa’, e quello dell’umile e fedele staffiere. Tutti gli altri, persino l’amato cavallo Berbero, l’hanno
tradito.
88 V, iv, didascalia dopo il v. 104 Siamo di fronte all’unica azione violenta di tutto il dramma. Nelle
fonti, Riccardo strappa l’arma di mano a uno degli otto sicari, e ne abbatte quattro. Gli odierni
storici ritengono invece che il Re fu lasciato morire di fame, o soffocato nel sonno. Commenta
H.C. Godard: «Strano a dirsi, l’ultimo atto di Riccardo è stato sovente ammirato come un gesto
di coraggio, un’estrema impennata di coraggio da parte di un codardo. Nulla di tutto ciò. [...] È
un impeto di pura disperazione, una fine particolarmente ignominiosa e ironica per un re che
s’illudeva di credere che tutto, dalle pietre agli angeli, gli sarebbe volato in soccorso nell’ora del
bisogno».
89 V, iv, 116 Il rimorso istantaneo del sicario ha precedenti in Shakespeare (Enrico VI, parte
seconda, III, ii, e Riccardo III, I, iv) oltre che in altri drammi contemporanei, a cominciare da
Edoardo II e Woodstock.
90 V, v, didascalia La scena è a Windsor, nella sala del trono.
91 V, v, 38-44 Il ripudio dell’esecutore da parte del mandante è un locus classico, a partire dalle Vite
di Plutarco (l’uccisore di Pompeo esecrato da Cesare). Basti ricordare il rimorso di Enrico II per
l’uccisione di Beckett (dove i cavalieri, anch’essi, non fanno che interpretare un accenno del